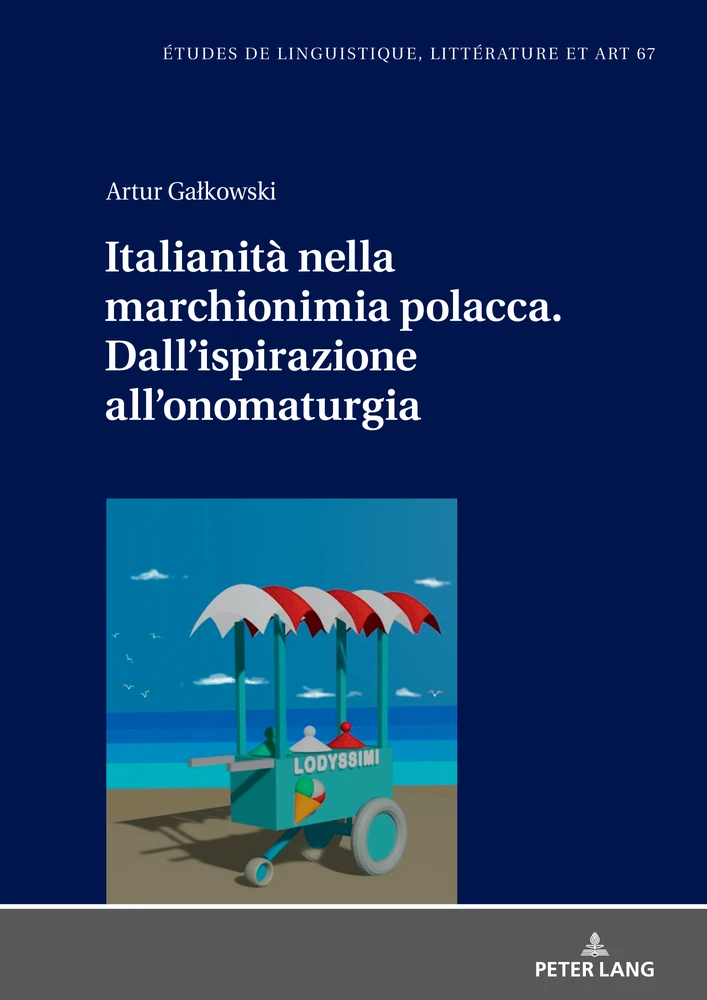Italianità nella marchionimia polacca. Dall’ispirazione all’onomaturgia
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Copertina
- Titolo
- Copyright
- Sull’autore/Sul curatore
- Sul libro
- Questa edizione in formato eBook può essere citata
- Sommario
- Introduzione
- Introduzione
- 1. Nozioni di base e inquadramento linguistico
- 1.1. Marchionimia
- 1.1.1. Marchionimia come categoria crematonomastica
- 1.1.2. Marchionimi e la discussione terminologica attuale
- 1.1.3. Permeabilità della marchionomastica e del branding
- 1.1.4. Stato della ricerca nella marchionomastica italiana
- 1.1.5. Stato della ricerca nella marchionomastica polacca
- 1.2. Formazione marchionimica
- 1.2.1. Onomaturgia marchionimica
- 1.2.2. Formazione italianeggiante
- 1.2.3. Circoscrizione della formazione italianeggiante in Polonia
- 1.3. Italianità
- 1.3.1. Italianità come italianismo
- 1.3.2. Italianità bene comune
- 1.3.3. Parole chiave dell’italianità nella comunicazione generale e digitale
- 1.3.4. Italianità e pseudoitalianità linguistica come forza persuasiva nella marchionimia
- 1.4. Inquadramento linguistico italo-polacco
- 1.4.1. Peculiarità della flessione
- 1.4.2. Aspetti della pronuncia
- 1.4.3. Attrazione e problematicità dell’ortografia
- 2. Vitalità dell’italianità codificata dall’italiano
- 2.1. Italiano lingua nazionale e internazionale
- 2.1.1. Italiano in Italia e italofonia
- 2.1.2. Italiano al di fuori dell’Italia e italsimpatia
- 2.1.3. Italiano in Polonia
- 2.2. Italiano lingua esportata e valorizzata nel contesto polacco
- 2.2.1. Il fenomeno della Little Italy
- 2.2.2. Le comunità italiane in Polonia
- 2.2.3. BreslaviAmo et al.
- 2.2.4. Italiano e italofilia nel Virtual Linguistic Landscape
- 2.2.5. Marchionimia culturale
- 2.3. Italiano lingua importata e performativa in Polonia
- 2.3.1. I polacchi in Italia
- 2.3.2. La rilevanza della mobilità delle donne
- 2.3.3. Viaggi in Italia e l’italiano in uso
- 2.3.4. Il branding dovuto alla conoscenza della realtà italiana
- 2.3.5. Marchi degli “pseudoitaliani”
- 2.4. Italiano lingua-cultura inclusiva dello strato appellativo e propriale
- 2.4.1. Italiano trasmesso accessibile a tutti
- 2.4.2. Culturemi terminologico-onimici
- 2.4.3. Strato appellativo vs. strato propriale dell’italiano
- 3. Fonti dell’ispirazione
- 3.1. Fonte marchionimica storica interna
- 3.1.1. Il marchionimo Bella
- 3.1.2. Il marchionimo Lubella
- 3.1.3. La serie dei marchionimi ispirati a Bambino
- 3.1.4. Pollena e il fascino delle geminate
- 3.1.5. Altri marchionimi italianeggianti storici
- 3.2. Fonte culturale deantroponimica
- 3.2.1. Esempi dei nomi italiani personali e personalizzati nella cultura polacca
- 3.2.2. Nomi dei personaggi inventati o recitati e l’italiano usato ad hoc
- 3.2.2.1. Bartolini e Pampalini
- 3.2.2.2. Prosilla, Prosiutta, Psinokio
- 3.2.2.3. Giuseppe a Varsavia
- 3.2.2.4. Francesco Rovanelli
- 3.2.2.5. Królowa Bona
- 3.2.2.6. Francesca Andreani
- 3.3. Fonte umoristica: esibizioni di cabaret
- 3.3.1. Włoch
- 3.3.2. Włoszka
- 3.4. Fonte musicale: canzoni del pop italiano
- 3.5. Fonte settoriale: linguaggio gastroalimentare italiano
- 3.5.1. Il linguaggio del caffè
- 3.5.2. Il linguaggio del vino
- 3.5.3. Il linguaggio della pasta
- 3.5.4. Il linguaggio della pizza
- 3.5.5. Gastroitalianismi in uso
- 3.5.6. Settore alimentare e creatività marchionimica
- 4. Analisi dei processi onomaturgici nella MPLI
- 4.1. Principi metodologici
- 4.1.1. Modelli e componenti dei marcatori d’italianità
- 4.1.2. Dimensione perionimica
- 4.1.3. Collocazioni e contesti
- 4.1.4. Concetto di modello prototipico
- 4.2. Descrizione dei dati e criteri di costituzione del corpus
- 4.2.1. Dati quantitativi di fondo
- 4.2.2. Criteri linguistici di selezione e di esposizione dei dati
- 4.3. Modellizzazione deonimica
- 4.3.1. Transonimizzazioni deantroponimiche
- 4.3.1.1. Nomi di battesimo maschili
- 4.3.1.2. Nomi di battesimo femminili
- 4.3.1.3. Nomi personali culturalmente attestati
- 4.3.1.4. Deantroponimici quasi-autenticati e non autenticati
- 4.3.1.4.1. Personalizzazione allusiva
- 4.3.1.4.2. Cognomi italiani fittizi
- 4.3.1.4.3. Abbinamenti di nomi e cognomi di fantasia
- 4.3.2. Transonimizzazioni detoponimiche
- 4.3.3. Altre transonimizzazioni
- 4.4. Modellizzazione neologica
- 4.4.1. Impronta deonimica
- 4.4.2. Neoformazioni ibridizzanti intergeneriche
- 4.4.2.1. Trasparenza e opacità nell’interpretazione neologica
- 4.4.2.2. Stilizzazioni su italianismi in polacco o polonismi in italiano
- 4.4.2.2.1. Fantasia ibridizzante
- 4.4.2.2.2. Pseudoadattamenti con refusi
- 4.4.3. Valori onomaturgico-pragmatici della MPLI neologica
- 4.5. La marchionimizzazione delle strutture monorematiche delessicali
- 4.5.1. Formazioni desostantivali o deaggettivali
- 4.5.1.1. Lessemi semanticamente motivati
- 4.5.1.2. Lessemi senza motivazione concettuale evidente
- 4.5.1.3. Lessemi con lo statuto di culturemi
- 4.5.2. Formazioni deverbali
- 4.5.3. Altre categorie grammaticali
- 4.5.4. Espressioni di cortesia e segnali discorsivi
- 4.6. La marchionimizzazione delle strutture sintagmatiche
- 4.6.1. Univerbazioni
- 4.6.2. Sintagmi preposizionali
- 4.6.3. Sintagmi nominali con aggettivi possessivi
- 4.6.4. Sintagmi nominali con aggettivi epiteto
- 4.6.5. Giustapposizioni, apposizioni, coordinazioni
- 4.6.6. Sequenze con un complemento preposizionale
- 4.6.7. Sequenze enunciative frasali
- 4.6.8. Sequenze enunciative d’ispirazione intertestuale
- 4.7. Formazioni paratattiche con lo statuto ibrido
- 4.7.1. Costruzioni con componenti inglesi
- 4.7.2. Costruzioni con componenti polacchi e internazionalizzati
- 4.8. Marcatori d’italianità distintivi
- 4.8.1. Lessemi garanzia dell’italianità linguistica
- 4.8.1.1. L’articolo la
- 4.8.1.2. Altri articoli
- 4.8.1.3. I numerali
- 4.8.1.4. L’identificatore antroponimizzante don
- 4.8.1.5. L’identificatore odonimizzante via
- 4.8.1.6. Il successo della famiglia lessicale di bellezza
- 4.8.1.6.1. bella
- 4.8.1.6.2. bello
- 4.8.1.6.3. bellissima
- 4.8.1.7. Gli aggettivi prospettici grande e piccolo
- 4.8.1.8. La trasparenza di tutto/-a/-i , molto , poco
- 4.8.1.9. L’epiteto dolce
- 4.8.1.10. L’aggettivo fresco e termini affini
- 4.8.1.11. Il poetismo amore e i suoi derivati
- 4.8.1.12. Il gastroitalianismo cucina
- 4.8.1.13. La qualità della “marca” gelato / gelateria
- 4.8.1.14. L’internazionalismo moda
- 4.8.1.15. Il termine-firma scarpa
- 4.8.1.16. L’uso marcato dei cromatonimi
- 4.8.1.17. Il coronimo Italia e l’etnonimo italiano/-a/-i/-e
- 4.8.2. Marcatori morfologici suffissali e desinenziali
- 4.8.2.1. Il modello -V
- 4.8.2.1.1. -aco, -eco, -ico, -ica, -igo, -ego, -ago
- 4.8.2.1.2. -ado , -ada , -oda , -odo , -adi , -edi
- 4.8.2.1.3. -ala , -ola , -olo , -oli , -elo , -ela , -ilo , -ile
- 4.8.2.1.4. -ano , -ana , -ani
- 4.8.2.1.5. -ino , -ina , -ini
- 4.8.2.1.6. -oni , -one , -ona , -eno , -ena
- 4.8.2.1.7. -ato , -ata , -ati , -eto , -eta , -ito , -ita , -iti
- 4.8.2.1.8. -amo , -emo , -imo , -omo , -ima , -imi
- 4.8.2.1.9. -ero , -ere , -aro , -ara , -oro , -ari , -eri , -ori
- 4.8.2.1.10. -asa , -aso , -oso , -osa , -ese , -esi
- 4.8.2.1.11. -avo , -ivo, -iva , -evo , -ovo , -ovi , -evi
- 4.8.2.2. I modelli -V
- 4.8.2.2.1. -aio , -aia
- 4.8.2.2.2. -aria , -ario , -oria , -eria
- 4.8.2.2.3. -VniV , -VliV , -VziV , -VdiV , -VpiV , -VsiV , -VciV , VgiV , -VbiV , -VviV
- 4.8.2.2.4. -eo , -ea
- 4.8.2.3. Il modello -V
- 4.8.2.3.1. -accio , -accia , -aggio , -occo , -acco , -ecco
- 4.8.2.3.2. -ella , -ello , -elli
- 4.8.2.3.3. -illo , -illa , -illi
- 4.8.2.3.4. -alla , -allo , -alli
- 4.8.2.3.5. -olla , -ollo , -olli
- 4.8.2.3.6. -etta , -etto , -etti
- 4.8.2.3.7. -otto , -otta , -otti , -itta , -atta , -atti
- 4.8.2.3.8. -asso , -assi , -issa , -isso , -esso , -essa
- 4.8.2.3.9. -azzo , -azza , -azzi , -ezzo , -ezza , -ezzi , -izzo , -izza , -ozzo , -uzzo
- 4.8.2.4. Il modello -V
- 4.8.2.4.1. -ando
- 4.8.2.4.2. -ante , -anto , -anti , -ento , -enta , -ente , -enti , -onto , -onti
- 4.8.2.4.3. -anza , -enzo , -enza , -onza
- 4.8.2.4.4. -ardi , -ardo , -ordi , -erdo , -erdi , -aldo , -aldi , -arno , -erna
- 4.8.2.4.5. -enda , -endi , -endo , -enso , -ensa
- 4.8.2.4.6. -esco , -esca
- 4.8.2.5. I modelli -V
- 4.8.2.5.1. -abile , -obile
- 4.8.2.5.2. -mento
- 4.8.2.5.3. -mente
- 4.8.2.6. Il modello -issimV
- 4.9. Sintesi sulla modellizzazione italianeggiante nella MPL
- 4.9.1. Il contesto e la tipologia delle motivazioni
- 4.9.2. La denominazione italianeggiante e la natura degli oggetti denominati
- 4.9.3. La distribuzione territoriale dell’interesse per l’italianità
- 4.9.4. Uno sguardo intersemiotico
Introduzione
[…] dove comincia e dove si ferma l’influsso dell’italianità? (Widłak 2009: 1997).
Va preso per scontato che nell’immagine culturale della Polonia di oggi è possibile notare un progredito e palese riflesso dell’Italia. Con l’Italia in questo presupposto intendiamo metonimicamente gli elementi e le manifestazioni della sua civiltà che da almeno sei secoli s’infiltrano in diverse sfere della realtà polacca. Generalizzando, ma in via ipotetica, si direbbe che l’oggetto d’interpretazione scientifica sia a questo punto la cosiddetta italianità, fenomeno alquanto discusso in vari studi umanistici, fino ad essere qualificato per mezzo di altre nozioni, che lo possono anche allargare concettualmente, p.es. italicità.
L’idea dell’italianità1, come ambito etnicamente radicato, ma allo stesso tempo fortemente internazionalizzato, attira l’attenzione degli utenti polacchi tradizionalmente simpatizzanti per il Bel Paese e gli italiani. Similmente ad altri popoli europei, ma in diverse misure, i polacchi vengono a contatto e accolgono con molta fiducia e interesse gli elementi d’italianità nella propria cultura.
Le testimonianze di questo impatto effettuato dall’Italia sono evidenti nella vita quotidiana: si tratta di fatti registrati nella lingua, nella cultura artistica, compresa anche quella popolare, nella letteratura, nell’industria e nell’infrastruttura sul territorio e nella società polacca, aperta a influssi stranieri. È un quesito di ricerca che è stato profondamente studiato e descritto, tanto da autori nella storia dei secoli scorsi, quanto nell’epoca odierna in cui il contatto con l’italianità, nel senso anche più articolato e molto più diretto, ma spesso superficiale, è largamente accessibile e non ostacolato o disturbato da barriere politiche, sociali o mentali. Anzi, è sempre alimentato da un affascinamento sincero e da una disposizione di apertura amichevole ed entusiastica, praticamente acritica.
Gli italiani non scendono, anzi salgono sempre nella classifica tra le nazioni più amate dal popolo polacco, occupando oggi il secondo posto dopo gli americani (conformemente alle statistiche del Centro di ricerca sull’opinione pubblica CBOS2 effettuate nel 2023, ben il 61 % dei polacchi esprime simpatia verso gli italiani mentre solo l’8 % professa antipatia).
Tenendo conto di queste circostanze molto determinanti per le ragioni dello sviluppo del fenomeno studiato, in questa sede vogliamo rivolgere l’attenzione scientifica ad un’area della diffusione dell’italianità nella realtà culturale polacca; ciò è giustificato dalla conseguenza immediata come sono percepite la lingua e la cultura italiana e dal prestigio ad esse attribuito in un tipo di comunicazione che necessita la creazione di nuove unità denominative. Si tratta della comunicazione commerciale in cui operano marchionimi, ovvero nomi commerciali intesi come segni denominativi distintivi di enti economici, fra cui soprattutto imprese o ditte e gli effetti della loro attività con scopi di lucro: prodotti e servizi offerti sul mercato polacco e internazionale.
In particolare, presentiamo i risultati di una ricerca linguistica nel campo dell’onomastica o, più precisamente, della crematonomastica, effettuando in modo possibilmente esaustivo la descrizione delle strutture e motivazioni, nonché dei valori comunicativo-culturali e pragmatici della produzione ossia della formazione dei marchionimi polacchi ispirati alla lingua (e alla cultura) italiana, che in questa ricerca sono ritenuti maggiormente come italianeggianti.
Sono strutture costruite con mezzi linguistici conosciuti dell’ambito lessicale (tra l’altro nell’area dei prestiti e dell’onomaturgia neologica), ma anche para-lessicologici che attingono lo stesso da fonti lessicali (elementi onimizzati) e propriali (elementi transonimizzati), non di rado impegnando stratagemmi di ibridizzazione. In generale, in questo tipo di processi si osserva un’avanzata liberalizzazione creativa con l’uso di strumenti non standardizzati a disposizione di autori non sempre pienamente attenti, coscienti e competenti.
È un dominio complesso che funziona malgrado una limitata o scarsa conoscenza generale dell’italiano da parte degli utenti polacchi, ma, paradossalmente, ciò non costituisce un fattore limitante l’ideazione di una data unità onimica ispirata ed effettivamente attribuita a concezioni stimolate e motivate direttamente o indirettamente dall’italianità. Anzi, il desiderio di introdurre un originale marchio linguistico italianeggiante è irresistibile e sembra essere considerato efficace in termini di marketing.
La diffusione della marchionimia polacca italianeggiante3 è dovuta alla percezione maggiormente intuitiva e inconfondibile delle caratteristiche strutturali morfo(fono)logiche e lessicali degli italianismi adattati e non adattati, ma anche voci create in modo neologico, compresi non pochi costrutti sintagmatici.
I polacchi recepiscono queste strutture e le accettano come sono. È una naturale conseguenza dei loro positivi atteggiamenti verso l’italianità e, particolarmente, la lingua-cultura italiana, i cui elementi si possono incontrare nel discorso della cultura di massa e mediale, culinario e alimentare, turistico e, in generale, commerciale. Conta qui una ragguardevole ammirazione della qualità Made in Italy (marche italiane, moda, stile, ecc.), nonché di un certo estetismo, considerato bello e raffinato, associato ai prodotti italiani.
Un impatto importante può essere costituito anche da una diffusione e attrazione interna delle forme marchionimiche italianeggianti già esistenti nell’ambito polacco che possono ispirare la creazione delle strutture simili e nuove. Nella marchionimia è un effetto che si traduce anche con il successo o la popolarità di marche già presenti sul mercato, i nomi delle quali diventano perfino prototipi di formazioni marchionimiche nuove (vd. p.es. i casi di Bambino o Lubella).
Nella nostra intenzione, innanzitutto, il volume completa un filone di ricerche onomastiche, linguistiche e di altre discipline, anche più applicative (p.es. nel branding), incentrate sullo studio della motivazione culturale e della strutturazione della MPLI, finora non concepite in modo monografico. In secondo luogo, la monografia propone risposte ai perché di questo fenomeno rilevando lo sfondo meno evidente della problematica, notata in diversi ambiti della vita quotidiana, degli interessi intellettuali e artistici, ma anche estetici o socio-ludici della cultura polacca moderna. Le nostre conclusioni possono essere confrontate con studi ulteriori in questa direzione scientifica e altri punti di vista da considerare, non solo nel contesto polacco. Avanziamo inoltre l’ipotesi che incidano anche sullo stato attuale (ma internazionalizzato) della lingua italiana, in interazione con altre lingue e culture.
In effetti, i fenomeni strutturali di una lingua A che influiscono e si manifestano in una lingua B sono fenomeni che appartengono non solo alla B, ma anche all’A, pur essendovi un distacco formale tra la A e la B, p.es. nella relazione tra italiano e polacco esaminato attraverso la marchionimia. Per la B sono fatti endolinguistici, per la A sono, invece, esolinguistici, ma ne confermano la capacità di disseminazione internazionale.
Nella prospettiva del funzionamento della lingua A, talvolta, si preferirebbe ignorarne la manifestazione al di fuori degli ambiti d’uso per i quali la lingua A, che ha riconoscimento ufficiale, è impiegata ai vari livelli di organizzazione (grammatica, lessico, registri, testualizzazione, standardizzazione).
Ancora più importante, in questa riflessione, è che non parliamo di un problema astratto. La penetrazione della lingua A nella lingua B, p.es. dell’italiano nell’ambito marchionimico polacco, quindi nella lingua polacca, avviene sempre più spesso senza interventi diretti degli utenti nativi della lingua italiana. È sicuro che il ricorso alla lingua italiana nella formazione marchionimica polacca è paragonabile ad altri casi di un simile fascino e attrazione della lingua italiana nelle culture europee e mondiali in cui la presenza dell’italiano è un effetto “transpolitico”, avvenuto spontaneamente e visibilmente quasi all’insaputa degli italiani stessi.
Tuttavia, vogliamo sostenere la tesi che malgrado il distacco tra la vera area territoriale e l’area creata come italiana in modo artificiale, ci muoviamo pure nel quadro del funzionamento della lingua italiana e della sua dimensione culturale, morale e giuridica. Per alcuni può essere un’affermazione inaccettabile, ma a nostro avviso una lingua non è un patrimonio che appartiene soltanto a una nazionalità, a una cultura, a uno spazio fisico e mentale.
Sul campo della relazione tra A e B, occorre ammettere anche l’intervento di una lingua C, considerati vari valori dell’internazionalizzazione della marchionimia italianeggiante (in generale, di ogni tipo di marchionimia). Da una parte, si tratta della via attraverso la quale gli influssi italiani s’infiltrano in polacco: non sempre direttamente dall’italiano4. Dall’altra, si prevede una prospettiva di processi di diffusione internazionale non ostacolati, perfino desiderati nel contesto della commercializzazione dell’offerta registrata in Polonia e aperta realmente o teoricamente (anche inconsapevolmente) ad altri Paesi. Infine, si crea un ampio spazio di formazione onimica (onomaturgia marchionimica) multilingue nella marchionimia in cui l’italiano (A) interagisce con un’altra lingua straniera (C) nel sistema linguistico polacco (B). Si entra in questo modo nell’ambito di fenomeni complessi di formazione, che non vanno trascurati per l’aspetto metodologico della nostra indagine.
Alla luce di questi presupposti, possono essere considerate altre ipotesi, non potendo essere escluso un coinvolgimento eventuale dell’italiano come attore passivo nella sua operatività comunicativa in un altro spazio linguistico che dall’italiano viene alimentato, allo stesso tempo alimentando in qualche modo l’italiano stesso. È un fenomeno che si può paragonare con quello che concerne la lingua inglese, ma certamente misurabile su un’altra scala.
La marchionimia è uno dei più importanti campi d’uso in cui si incontrano diverse lingue su un territorio nazionale. Nel contesto polacco emerge l’ipotesi che l’interferenza motivata dalla lingua-cultura italiana sia una delle più forti e visibili nella produzione dei marchionimi che attestano degli espliciti influssi stranieri.
L’italiano è un idioma verso cui i polacchi, creando i marchionimi, si rivolgono con un interesse straordinario, radicato e conseguente ad un bisogno di esoticizzazione e assegnazione di originalità e attrattività ai nomi commerciali e ad altri crematonimi che compaiono nei confini utilitaristici dell’onimia polacca.
Le nostre osservazioni e le analisi su campioni possibilmente rappresentativi per la categoria onimica e linguistica studiata, portano a credere che l’italiano si manifesti nella marchionimia polacca5 in modo paragonabile o anche maggiore dell’inglese, ma ciò dipende anche dai settori che si sottopongono a tale analisi.
Allo stesso tempo dobbiamo sottolineare che in questo studio non siamo in grado di confrontare l’entità degli influssi italiani e inglesi, tuttavia, non abbiamo potuto ignorare una rilevante presenza dell’inglese nelle forme ibride che si possono qualificare sia come italianeggianti, sia come anglicizzanti nell’area della MPL. Queste forme “dubbie” non sono state escluse dalla nostra analisi, considerando il loro potenziale molto creativo e caratteristico nei processi di ibridizzazione marchionimica.
La monografia si compone di quattro capitoli divisi in paragrafi e sezioni e sottosezioni. Lo studio è stato pensato come un’elaborazione di un background teorico e illustrativo (Capp. 1–2), cui segue un campione di fatti linguistico- culturali che possono essere interpretati come fonti dell’ispirazione italiana in Polonia (Cap. 3), fino ad un’analisi dettagliata del nostro corpus marchionimico, frutto di un lavoro di ricerca nelle fonti ufficiali, nonché negli spazi pubblici, principalmente quello presente virtualmente in Rete dove vengono collocati i nomi sottoposti alla nostra analisi crematonomastica (Cap. 4).
Il Cap. 1 è dedicato alla spiegazione delle nozioni di base (termini teorici che incorniciano la ricerca: marchionimia, italianità e formazione / onomaturgia), nonché ad una caratteristica di alcuni elementi di grammatica delle due lingue a contatto, significativi dal punto di vista dell’analisi strutturale e comunicativo- culturale dei marchionimi raccolti nel corpus di ricerca.
Il Cap. 2 mette in rilievo uno sguardo sull’italiano, lingua con un potenziale vitale molto caratteristico non solo per i parlanti nativi che la usano, ma anche per la cultura europea e globale. Malgrado non sia diffusa quanto le altre lingue straniere del primo cerchio d’interesse come: inglese, spagnolo, tedesco o francese, per certe ragioni storiche e attuali è diventata e continua ad essere la materia che permea nei linguaggi specialistici di altri idiomi e, a sorpresa o meno, supporta spontaneamente la formazione di unità marchionimiche appartenenti a diversi sistemi comunicativi, come p.es. quello polacco. Apparentemente, il polacco sembra essere, per ragioni storiche e soprattutto linguistiche, un sistema chiuso alle influenze di altri idiomi “occidentali”, comunque, i fatti dimostrano una sua idoneità a inserire gli influssi stranieri nella propria marchionimia, tra cui gli espliciti influssi italiani, facendo sì che il polacco sia diventato via via, in questi ultimi decenni, un idioma sempre più consapevolmente aperto e accogliente.
Nel Cap. 2 cerchiamo inoltre di spiegare che nella sua complessità appellativo-propriale, l’italiano assume lo statuto della lingua-cultura che invita gli “ospiti” interessati, fornendo loro modelli strutturali e concettuali universalmente applicabili anche in altri sistemi culturali e linguistici. Nonostante si dichiari una certa crisi dell’italiano, la lingua e la cultura italiana rimangono un ambito di riferimento e fonte d’ispirazioni notevoli. Per lo più vengono sempre considerate un bene e patrimonio comune dell’umanità non solo riservato all’Italia e agli italiani. È rilevante che nella sua complessità, costituita dal linguaggio generale e da quello onimico (che consideriamo parte indispensabile della lingua), l’italiano continua ad essere oggetto d’interesse, manifestato attraverso vari atti e testimonianze in altre lingue e culture.
Nel Cap. 3 si discutono alcuni ambiti ed esempi di motivazione diretta e indiretta che presentano un impatto misurabile nella produzione dei marchionimi italianeggianti in Polonia: i nomi commerciali polacchi storici, basati su strutture italiane; i nomi propri italiani che rinviano a personaggi veri o fittizi, ma emblematici per la percezione pubblica; i giochi con la lingua italiana nei testi del cabaret polacco; i gastroitalianismi che si adottano con tutto il piacere di avere l’accesso alla cucina e ai prodotti italiani Polonia. Principalmente, si tratta di categorie d’ispirazione che emergono nella vita quotidiana e sono maggiormente frutto dei segni dell’italianità nella cultura di massa in Polonia.
La scelta di ispirazioni possibili permetterà di capire dove si possono trovare le tracce dell’italianità codificata in numerosissimi marchionimi polacchi. È un fenomeno caratteristico per l’epoca contemporanea ma non senza qualche testimonianza storica, anche motivante in questo caso e per questo citati. Rileviamo alcuni tentativi rimarcabili nei decenni di prima della fine del comunismo in Polonia e perfino tra le due guerre, tuttavia, l’attenzione particolare viene posta sulla MPLI prodotta e registrata sin dagli anni ’90 del XX sec. e nei tempi più recenti.
L’analisi onomastico-linguistica della nostra raccolta si colloca nel Cap. 4. La raccolta la riteniamo un corpus di nomi-citazioni, attestati come microtesti in varie fonti del sistema amministrativo e della comunicazione commerciale in Polonia, tra l’altro i registri statali ufficiali e gli elenchi con dati di contatto. Sono informazioni pubblicamente accessibili, anzi funzionanti come messaggi pubblicitari che gli imprenditori vogliono diffondere per naturali scopi commerciali. Nondimeno, nella nostra sistemazione li menzioniamo in contesti minimi senza dettagli precisi, p.es. sull’indirizzo fisico preciso dell’esercizio aziendale, sui numeri identificati o nomi e cognomi degli imprenditori. Quando citiamo un nome di battesimo o un cognome di una persona fisica, lo facciamo per stretti scopi di ricerca linguistica, giacché è indispensabile per rendere più chiara la giustificazione della motivazione del firmonimo, omettendo, comunque, dati ulteriori che potrebbero far identificare direttamente una persona fisica6.
Alla raccolta dei marchionimi selezionati per il corpus non abbiamo posto limiti che riguarderebbero la definizione preliminare delle loro strutture formali, la natura degli oggetti da essi designati o l’assegnazione amministrativa territoriale (voivodato), affinché il campione sottoposto all’esame fosse il più rappresentativo per l’ambito sottoposto allo studio. Per questo, dal punto di vista linguistico, i nomi dei marchi aziendali che firmano l’attività individuale o sociale (produzione, servizi o commercio) sono considerati nella stessa maniera: come fatti onomastici che illustrano lo stesso fenomeno. È il criterio principale che ha guidato l’individuazione di unità marchionimiche che si possono riferire a elementi particolari della lingua e cultura italiana. La loro assegnazione tipologica evidenzia casi palesi, manifestati sul piano dell’espressione. L’effetto italianeggiante è quasi sempre progettato dagli autori dei nomi, ma interpretato dagli utenti con diverso successo.
Tuttavia, il riconoscimento dell’italianità nelle forme studiate non avviene con scarsa frequenza. La lingua italiana è troppo distintiva, sia nel contesto polacco, sia comparandola con altre lingue che entrano in gioco. Le ispirazioni sono di solito meno sublimi di quanto si potrebbe aspettare in questo tipo di circostanze. L’uso dell’italiano può essere perfino causato da un impulso di affascinamento o piacere dovuti a indizi isolati (nomi di personaggi, nomi geografici, nomi di opere d’arte, nomi di marche italiane, unità terminologiche, citazioni di singole voci ed enunciati categorizzati come italianismi o prestiti e occasionalismi nel linguaggio polacco, culturemi lessicali, ma anche determinati dai caratteristici suffissi o suffissoidi d’origine italiana, considerati una forma di marcatori speciali dell’italianità linguistica).
Il volume termina con una discussione e una ricapitolazione generale sui fatti marchionomastici osservati. Per facilitare la ricerca di un singolo marchionimo come lemma linguistico attestato, si aggiunge al volume l’indice alfabetico delle unità marchionimiche sistemate e analizzate. La bibliografia contiene gli indirizzi delle pubblicazioni consultate cui ci siamo riferiti nel contenuto della monografia. Vengono evidenziate inoltre le fonti dei dati analizzati e di alcuni materiali di riferimento, p.es. statistici e illustrativi. I lettori non italofoni possono trovare due riassunti del libro: in polacco e in inglese.
***
Esprimo i miei più vivi ringraziamenti a tutti coloro che mi hanno sostenuto nella stesura di questa monografia, in particolare il prof. Giovanni Gobber dell’Università Cattolica del Sacro Cuore per la recensione e per tutti i suggerimenti trasmessi; il direttore della Rivista Italiana di Onomastica Enzo Caffarelli per la sua lettura e per le varie osservazioni nella parte “onimica” del capitolo analitico; nonché il dr. Ilario Cola, collega e amico per la correzione linguistica e per i tanti dei suoi preziosi consigli, oltre che per una discussione accademica di cui siamo partecipi da quasi 30 anni. Ringrazio inoltre il prof. Rafał Zarębski e la dr. Monika Tosik per la lettura dei riassunti polacco e italiano del volume.
1 L’introduzione del concetto di italianità negli studi linguistici del contatto fra italiano e polacco è dovuta a Stanisław Widłak (2000; cfr. id. 2009: passim; id. 2010: 23, 36, 47; anche id. [a c. di] 1997). L’equivalente polacco di italianità è włoskość [ˈvwɔskɔɕʨ̑] (sull’origine dell’etimo della radice pol. włosk- cfr. infra, spec. nota 165). Nella versione polacca è un termine relativamente nuovo negli studi linguistici, letterari e in altre discipline (cfr. p.es. Słapek 2021; Ozimska 2021; Klimkiewicz 2021); è utilizzato in vari linguaggi e stili, nella comunicazione giornalistica tradizionale e sui social (spesso come la parola chiave passepartout in riferimento all’Italia e alla cultura italiana; vd. p.es. l’enunciato pubblicitario della marca Dr.Oetker pol. Włoskość na wyciągnięcie ręki? Poznaj Felicianę, pizzę z włoską historią! [lett. L’talianità a portata di mano? Ecco Feliciana, una pizza con una storia italiana!; trad. AG], https://pizzafeliciana.pl, u.a. 30.04.2024).
2 Pol. Centrum Badania Opinii Społecznej.
3 Da ora in poi useremo il simbolo MPLI.
4 Vd. il termine panini (cfr. Sez. 3.5.6), nella lingua-cultura polacca preso in prestito dall’inglese, oppure lo pseudoitalianismo tutti frutti utilizzato dapprima nell’area inglese-americana e poi anche germanofona (cfr. un famoso brano rock degli anni ’50 del XX sec. di Little Richard intitolato Tutti Frutti; l’ispirazione originaria sarebbe dovuta venire dai nomi dei gusti di gelato in una gelateria a New Orleans, vd. https://web.archive.org/web/20031125050026/http://www.rockabilly.nl/references/messages/dorothy_labostrie.htm, u.a. 25.02.2024; cfr. anche Hendrykowski 2018).
5 Da ora in poi si usa il simbolo MPL.
6 Rispettiamo il regolamento generale sulla protezione dei dati RGPD (regolamento UE 2016/679) trattati per scopi scientifici, come pure l’art. 34 della Legge polacca del 4 febbraio 1994 sul diritto d’autore e sui diritti connessi. In particolare, indichiamo la fonte del firmonimo citato la quale rinvia ai dati identificativi dettagliati degli intestatari resi pubblici. Lo stesso riguarda le illustrazioni che vengono accompagnate dall’indicazione della fonte, p.es. nelle pubblicazioni amministrative dello Stato polacco, specialmente i Bollettini dell’Ufficio Marchi e Brevetti della Repubblica Polacca = WUP (pol. Wiadomości Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej).
1. Nozioni di base e inquadramento linguistico
Una data lingua etnica non è un’entità incorniciata come complesso finito e chiuso, ancora meno come sistema immobile. Si dà per scontata la sua variabilità diacronica e sincronica, ma non tutte le sfere del sistema cambiano con la stessa intensità. Si notano cambiamenti al livello del vocabolario che apparentemente perde le sue voci (p.es. quelle che da tempo sono diventate arcaismi) e ne assorbe nuove (p.es. termini nei linguaggi settoriali necessari per trasmettere messaggi specialistici). Contemporaneamente, tanti notevoli e continui processi di arricchimento o riduzione di unità linguistiche sono osservati nella sfera che accompagna il lessico, e cioè nell’ambito propriale indispensabile per l’individualizzazione e l’orientamento identificativo tra gli oggetti della realtà extralinguistica.
Il patrimonio linguistico è un serbatoio sempre aperto in cui si distingue il vocabolario con le sue facoltà morfo-sintattiche, semantiche e comunicativo- pragmatiche. Ma non meno rilevante è l’esistenza di elementi collaterali o complementari costituiti da onimi rappresentati da diverse categorie e sottocategorie onomastiche, maggiormente nomi personali, nomi geografici, nomi di entità culturali.
L’onimia, a differenza del lessico comune, è un ambito linguistico di strutture non arbitrarie. Gli onimi vengono creati come unità strutturalmente e culturalmente motivate, spesso ispirate da obiettivi e circostanze specifiche, come l’interscambiabilità tra le lingue. Ad esempio, nell’antroponimia di una data lingua si osserva l’adattamento di tanti nomi di battesimo originari di lingue e culture anche molto diverse, ma accolte per ragioni ideologiche, estetiche, epocali, legate alla tradizione o per l’interesse di mantenere un riferimento alla propria provenienza oppure per distinguersi in modo più marcato del solito.
Un fenomeno simile e ancora più articolato viene adoperato nei processi di creazione dei nomi commerciali che hanno letteralmente bisogno di una diversificazione avanzata per poter funzionare come possibilmente unici e irrepetibili. Con supporto linguistico esteriore, e cioè l’uso di una lingua straniera, si riesce a raggiungere questo scopo, soddisfacendo l’intenzione dell’autore del nome che propone ai riceventi qualcosa di non comune ma allo stesso tempo non troppo estraneo.
Oggi, infatti, il movimento interlinguistico, anche se non proporzionale fra una lingua e l’altra, si osserva nella crematonimia, e specialmente nella sua classe che comprende i nomi commerciali intesi in onomastica come marchionimi. In certe aree, questo fenomeno assume dimensioni spettacolari come testimonianza di atti letteralmente desiderati e guidati da onomaturghi motivati da determinate tendenze e preferenze, malgrado l’esistenza e l’area d’interesse delle strutture marchionimiche possano essere limitate nelle dimensioni dell’uso.
L’onimia nuova, rappresentata maggiormente da marchionimi, come pure il lessico speciale in varie terminologie, costituiscono una risposta concretizzata ai bisogni della comunicazione che cerca di accompagnare lo sviluppo della realtà socio-economica. I nomi commerciali assumono in questa situazione funzioni quasi lessicali fino al punto di passare il confine tra nomina propria e nomina appellativa7, soprattutto quando diventano elementi dell’enunciazione (comunicazione quotidiana, discorso specializzato, pubblicità, linguaggio mediale, ecc.)8. Comunque, al livello strutturale non si rivelano così regolari e sistemici come lessemi, giacché si servono di modelli di formazione non normativi e sconosciuti per il vocabolario della lingua generale.
1.1. Marchionimia
Nelle scienze onomastiche maggiori (antroponomastica, toponomastica e crematonomastica9) si distinguono termini nodali che funzionano come operatori tassonomici nella descrizione dei fatti onomastici. Il loro ruolo è cruciale per orientarsi nel mondo dei nomi propri. Costituiscono concetti metalinguistici (ovvero metaonomastici) su cui si poggia la distinzione degli onimi in diverse categorie. È interessante che questa distinzione sia di natura convenzionale. Per questo è possibile attribuire a nomi come Marco, San Pietro, Prada, Venezia, Bacio funzioni e relazioni che rinviano a individui o oggetti veri o potenziali nella realtà extralinguistica.
La capacità denotativa dei nomi citati e di molti altri non è univoca. Non sono lessemi con significati semantici che formano delle definizioni stabilite e fisse almeno al livello delle accezioni principali di una parola appartenente al vocabolario della lingua generale. Dal punto di vista puramente linguistico sono sostantivi che appartengono alle categorie antroponomastiche, toponomastiche e crematonomastiche. Dal punto di vista culturale sono indicatori pragmatici che designano i referenti su cui si può dire qualcosa di concreto o ipotetico. La loro peculiarità consiste nella capacità di polidesignazione che non conosce restrizioni naturali nella comunicazione. Possono facilmente lasciare il loro campo originario e passare a un altro che è più vicino nella stessa categoria onimica o più lontana in una categoria onimica diametralmente diversa o addirittura opposta. Si tratta in questi casi di processi di transonimizzazione.
Ad esempio, Marco, come antroponimo con funzione di nome di battesimo attribuito ad un uomo concreto chiamato Marco, oppure potenzialmente attribuibile ad un uomo con la stessa condizione identificativa, può anche essere tramandato nel campo della toponimia o crematonimia dove designa un luogo o un oggetto materiale o virtuale. Ancora più marcata in questa prospettiva è la capacità del nome Venezia, senza esitazione interpretato come un urbonimo fisiograficamente e culturalmente determinato, ma ciò dipende dalle conoscenze dell’utente, in questo caso piuttosto universali e non generanti ambiguità. D’altra parte, una relativa ambiguità è possibile quando lo stesso nome denota un altro luogo geografico, un posto nella topografia urbana, fa da cognome o altro nome personale speciale, ovvero denomina un oggetto o un’attività, essendo un marchio nell’area economica.
Non sorprende poi il loro passaggio tra le lingue, quando le strutture così leggibili per quanto riguarda la loro origine passano in un’altra lingua e, pur create con mezzi linguistici italiani, funzionano fuori dall’ambito d’origine strutturale e/o semantico (p.es. molte aziende polacche denominate appunto Venezia).
La categoria marchionimica assorbe ogni tipo di creazione e, come vogliamo dimostrare, la MPL da tempo e sempre con un’intensità notevole e ben distinta s’ispira alla lingua e cultura italiana, instaurando un marchionomasticon speciale al livello linguistico e comunicativo (denotativo e connotativo).
1.1.1. Marchionimia come categoria crematonomastica
Il termine marchionimo è utilizzato in italiano come operatore tassonomico10 principale della marchionomastica intesa come branca della crematonomastica11. È equivalente specialistico di nome commerciale o di marchio (marchio presentato in forma linguistica)12. Il formante -onimo gli aggiudica espressamente lo statuto di onimo, a prescindere da una discussione continua sulla sua natura: propriale (di nome proprio) e/o appellativa (di nome comune)13.
Come unità linguistiche fondate su elementi costitutivi d’aspetto semplice o composto (delessicale o depropriale), i marchionimi possono designare esemplari di diversi tipi di oggetti: imprese di carattere aziendale e prodotti o servizi, quindi enti materiali e immateriali, individualizzati o perfino unici come realtà (p.es. una concreta ditta) o introdotti sul mercato in serie (p.es. prodotti fabbricati dalla stessa ditta e sotto lo stesso nome che assume spesso lo statuto di marca).
La nostra è una visione panoramica della marchionomastica, giacché non si dovrebbe a nostro avviso, staccare e riservare il marchio solo a prodotti o servizi, entità commercializzate. Il significato del marchio si protrae verso una prospettiva più ampia e completa, nella quale rientrano anche i produttori intesi come ditte o aziende e i risultati della loro attività artigianale, industriale o commerciale. In un’altra sede abbiamo chiamato quest’area naming commerciale14.
L’area marchionimica va intesa come altre aree denominative complesse. È ovvio, p.es., che l’antroponimia non comprende soltanto nomi di battesimo e cognomi; la toponimia non annovera soltanto nomi di località. La natura degli oggetti antroponimici e toponimici varia e i loro nomi assumono diversi ruoli funzionali, come p.es. i nick nella comunicazione virtuale o i nomi delle vie, strade, autostrade nei sistemi amministrativi. Così pure il marchionimo non ha una natura omogenea, se osserviamo i suoi possibili referenti economici intorno ai quali si sviluppa una marca. Possiamo quindi considerare i marchionimi anche come unità denominative che indentificano produttori, fornitori e venditori di prodotti e servizi.
Crediamo che ogni tipo di marchionimizzazione15 illustri i fenomeni studiati in riferimento all’interferenza italiana nella formazione dei marchionimi italianeggianti nell’area polacca.
1.1.2. Marchionimi e la discussione terminologica attuale
Come struttura terminologica metaonomastica il termine marchionimo è da considerare come sinonimo di nome di marchio o dell’internazionalismo brand name, ridotti, per metonimia, a marchio o brand. Il termine chiave della marchionomastica sta assumendo dimensioni interdisciplinari nell’ambito delle scienze umane, soprattutto in linguistica e semiotica, ma anche in altre discipline relative alla sociologia, alle scienze culturali, al diritto, e infine all’economia e al management, o più in generale al marketing, come spazio di interesse e applicazione comune nella cultura socio-economica contemporanea16.
In sostanza, il marchionimo “potrebbe […] definirsi come la denominazione di quella porzione del marchio che ha carattere linguistico (e non iconico, sonoro, ecc.)” (Caffarelli 2018d: 997), ma bisogna osservare che è un segno con funzioni multimodali rivolte allo spazio di segnalazione visuale, soprattutto quando i marchionimi diventano la base del logo. Funzionano allora come logonimi, ossia come nomi commerciali presentati graficamente nella veste logotipica, come nel linguaggio della pubblicità con valori semiotici particolari17. I logonimi rappresentano la marca che “è chiaramente un dispositivo semiotico, che trae origine da un vero e proprio segno, quel marchio che nell’uso americano si chiama «logo», il quale in sostanza è un nome proprio, di solito caratterizzato anche da una certa morfologia assai precisa (un lettering, un colore, un grafismo particolare)” (Volli 2003: 83–84).
Nella nostra ricerca usiamo anche un altro sinonimo di marchionimo, ed è firmonimo18, il quale peraltro è piuttosto un tipo nella classe dei marchionimi. Il firmonimo risulta una delle istanze del marchionimo – esso si trova quando il nome di marchio indica specificamente una ditta o un suo frutto di commercializzazione, e si pone come un simbolo fondato su un’unità linguistica esistente fuori della marchionimia o creato come neoformazione. Si usa specialmente per indicare l’esercizio economico di un singolo imprenditore che ha il diritto a registrare il termine come aggiunta ai suoi dati, la quale tuttavia non è identificativa al livello personale, se non si indicano il nome e cognome dell’intestatario/a della ditta, l’indirizzo della sede o un numero sui registri amministrativi ufficiali (p.es. l’identificatore fiscale)19. Dal punto di vista comunicativo e marchionomastico, è un simbolo verbale della firma20 il quale funziona come ogni altro nome aziendale designante strutture di ragioni sociali più complesse.
Ciò è stato precedentemente esposto anche in una nostra pubblicazione recente in francese (Gałkowski 2019a: 99–100):
Je crois que le terme [firmonimo] garantit l’universalisation de sa portée dans la taxinomie sémantique et fonctionnelle de différents types et étapes du nom commercial (angl. Trade Mark, it. nome di marchio ou marchionimo, russ. товарный знак). Les équivalents français ou autres de ce vocable : fr. firmonyme, angl. firmonym, it. firmonimo, russ. фирмоним, etc. peuvent être dès lors soumis à la discussion. Notons que le polonais firma comme d’ailleurs le français firme, l’anglais firm ou encore l’allemand Firma vient de l’italien firma qui veut dire « signature » (alors un signe qui fonctionne en tant que logo) mais aussi « confirmation, attestation d’un engagement », « raison sociale » (v. <http://www.cnrtl.fr/etymologie/firme>, dernière consultation : 16/05/2017). Le terme firmonyme correspond bien aux noms d’entreprises ou d’exercices commerciaux (d’activités commerciales) mais au fond il est aussi valable pour les noms de marques ou de produits qui sont immanquablement associés à une entreprise sous une marque donnée.
Il termine universale alternativo ed esplicativo del marchionimo è inoltre l’ingl. business name, ma neanche questo soddisfa tutte le opportunità del funzionamento del marchionimo (marchio linguistico). Lo spiega Paula Sjöblom (2014: 93) riferendosi alla casistica internazionale, soprattutto quella scandinava:
A company name (also business name) is an expression which consistently refers to a certain business. With this name, a company is identified and its activities distinguished from other companies. In German studies, the term Unternehmensname, in Swedish företagsnamn and in Finnish yritysnimi (‘enterprise name’) are often used in the same sense. However, if we discuss it in depth and also take legal aspects into consideration, these terms are not unambiguous. For example, the Finnish Trade Names Act uses the term toiminimi (‘acting name’, in Swedish firma) which refers to names of all kind of financial actors from private entrepreneurs to cooperatives and listed corporations […]. The same word toiminimi in colloquial Finnish refers to the name of a private entrepreneur. To make matters even more complicated, the English term company name does not literally correspond to the terms in these other languages. One must also remember that all businesses are not companies (in Finnish yhtiö from the verb yhtyä ‘to combine’) in a strict sense, as we take, for example, private entrepreneurs, who do not share their entrepreneurship with a partner. Nor, on the other hand, can all companies be considered businesses that practise economic activity (e.g. housing cooperatives). When studying company names, the researcher must be aware of the business legislation and trade name legislation of the country in question, because the law determines what kind of companies can exist, sets limits to company names and regulates them.
Si ricordi poi la differenza tra ergonimo e pragmonimo (oppure pragmatonimo). E l’uno e l’altro sviluppano la loro proprietà terminologica con equivalenti che mantengono nella loro struttura le basi provenienti dal greco: ergo- (con il significato corrispondente al concetto di lavoro e/o di frutto del lavoro) e pragmo-/pragmato- (attinente al concetto di “produzione dell’ingegno umano”, Caffarelli, Gagliardi 2018: 46), p.es. ingl. ergonym21 e slovac. pragmatonymum, entrambi ritrovabili nella categoria dei crematonimi22.
I confini semantici di questi due termini sono incerti e s’intrecciano fino al punto di diventare sinonimi, ma è ergonimo a prevalere negli studi onomastici internazionali, costituendo allo stesso tempo l’equivalente di marchionimo nella definizione massima di questo concetto (nome di un ente economico: azienda, prodotto, servizio23) corrispondente al ted. Handelsname ‘nome commerciale’ secondo la teoria di Theodolius Witkowski (1964: 36): “nomi di imprese e denominazioni di aziende o ditte sia nomi di prodotti” (Fischer 2008: 134)24.
Si sa da dove vengono i nomi commerciali, che spesso sono anche marchi registrati e come tali considerati in questa sede, ancorché alla stessa categoria potrebbero appartenere pure i nomi di impresa, i cosiddetti ergonimi. […] Gli uni e gli altri rispondono alla funzione di espressione rispetto all’emittente, di appello rispetto al ricevente e di rappresentazione rispetto alla realtà denotata (Coletti 2009: 1).
Chiudendo la rassegna terminologica, va aggiunto che è entrato nell’uso scientifico anche il termine crematonimi di marketing proposto nella nostra teoria sui crematonimi25. È l’equivalente del pol. chrematonimy marketingowe e funziona anche in altre lingue. Il concetto ha un valore iperonimico, ma lo possiamo anche trattare come sinonimo funzionale di marchionimo, inteso come nome di un’entità economica categorizzata in modo ampio (cfr. Gałkowski 2014c: 83).
La portata culturale codificata nei crematonimi di marketing (marchionimi) rinvia inoltre all’idea di onomastica commerciale (fr. onomastique commerciale, Fèvre-Pernet, Roché 2005; Fèvre-Pernet 2008; considerata anche nel contesto interdisciplinare, cfr. Gałkowski 2019: 97), che è la continuazione della linguistica delle insegne (fr. linguistique des enseignes, Pottier 1947), nonché della linguistica industriale (Migliorini 1927: 75)26.
1.1.3. Permeabilità della marchionomastica e del branding
A quanto ricordato da Fiorenza Fischer (2008: 135) a proposito di Ökonyme (vd. la citazione in nota 11), la problematica dei marchionimi permea lo stesso negli studi onomastici (marchionomastici / ergonomastici / crematonomastici) e nel campo d’interesse più applicabile che spetta al marketing, particolarmente al branding.
Il branding è diventato un importante settore economico che si fonda su un’attività intellettuale con la consapevolezza del ruolo che svolge il nome del marchio nello sviluppo e nel successo di un ente economico sul mercato27. Il marchio linguistico come un fatto d’espressione per eccellenza accumula funzioni pubblicitarie e perfino persuasive28.
La produzione di un marchionimo è un atto di formazione (ovvero di onomaturgia intesa nel senso marchionomastico come creazione di nuovi onimi; cfr. Par. 1.2) che si effettua una sola volta, senza prevedere tutte le conseguenze che corre l’imposizione di una data forma linguistica all’oggetto della denominazione. Ma può essere anche un’arte guidata da esperti che se ne occupano studiando tutti i rischi e pregi di una creazione ordinata come prodotto in sé stesso29. La seconda opportunità permette di creare proposte di nomi che rispondono ad un complesso di requisiti di un sofisticato marchionimo in modo programmato.
Il marchionimo come elemento simbolico e identificativo può articolarsi in informazioni ufficiali, amministrative e pubblicitarie a proposito di una realtà economica30, ma anche altri elementi che compongono normalmente un brand nella prospettiva multimodale (linguistica e grafico-visuale).
The visual distinctiveness of a brand may be a combination of any of the following: names, letters, numbers, a symbol, a signature, a shape, a slogan, a colour, a particular typeface. But the name is the most important element of the brand as its use in language provides a universal reference point. The name is also the one element of the brand that should never change (Blackett 2003: 15–16).
La caratteristica del nome di un marchio è quasi fisica (reificata). Tale caratteristica si manifesta nella sua rappresentazione grafica associata al referente insieme a valori da esso codificati. “Il nome appartiene all’identità visiva della marca, perché […] è in grado di evocare e produrre immagini mentali” (Fabris, Minestroni 2004: 218).
È un fenomeno complesso che si fonda su una certa operatività tecnica. Di principio, non sfugge agli obiettivi dei grafologi ed altri esperti della comunicazione visiva.
Il termine “marchio” indica un segno visivo che rappresenta una persona, un’azienda, un ente o un’identità e che diventa riconoscibile, da parte dell’osservatore, differenziandosi dalla concorrenza. È il segno grafico di riferimento dell’azienda, che “marchia” i suoi prodotti dichiarandone l’appartenenza e tutelando la sua esclusività da un punto di vista formale e legale. È l’immagine che l’azienda vuole dare di sé al mondo esterno, in modo da farla riconoscere in tutti i contesti in cui essa opera e si presenta. L’immagine grafica di un marchio è strettamente legata ai valori e alle parole chiave che definiscono la filosofia aziendale: progettare un marchio è un lavoro complesso che presuppone la conoscenza approfondita dell’azienda da rappresentare per comunicare l’idea (il concept) attraverso richiami visivi simbolici. Il marchio deve comunicare attraverso un linguaggio visivo semplice e sintetico (Mapelli 2021: 91).
“Everything a brand does is a communication” (Feldwick 2023: 127), ma è il suo nome che è capace di suggerire certe concettualizzazioni e connotazioni in linea performativa, informativa, qualificativa e perfino sensitiva31. “Il naming di un brand e il logo ad esso abbinato possono infatti essere utilizzati per fornire un’immediata categorizzazione dello stesso in termini di attributi (ad es. Kinder Pan&Cioc), benefici (ad es. Vitasnella) e target di riferimento (ad es. Polo Ralph Lauren)” (Gabrielli 2014: 20).
Come unità comunicativa il marchionimo entra in una semiosfera che comporta proprietà sociali e utilitarie, indispensabili per raggiungere scopi di lucro ovvero commerciali32, creando intorno a sé una “storia”, una “filosofia” o una “personalità”, cioè un significato che si estende proporzionalmente alla notorietà dell’oggetto della commercializzazione. Nella teoria della marca, il nome del marchio acquista la capacità di illustrare, raccontare, spiegare (Fabris, Minestroni 2004: 222).
Details
- Pages
- 648
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9783631925027
- ISBN (ePUB)
- 9783631925034
- ISBN (Hardcover)
- 9783631921531
- DOI
- 10.3726/b22224
- Language
- Italian
- Publication date
- 2024 (December)
- Keywords
- inspiration word formation neologisms Italianisms pseudo-Italianisms Italianity marketing communication Polish Italian linguistic contact linguistic landscape markonyms brand names trade names branding onomastics chrematonomastics Italian sounding onomaturgy motivation
- Published
- Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 648 pp., 303 fig. col., 139 fig. b/w, 10 tables
- Product Safety
- Peter Lang Group AG