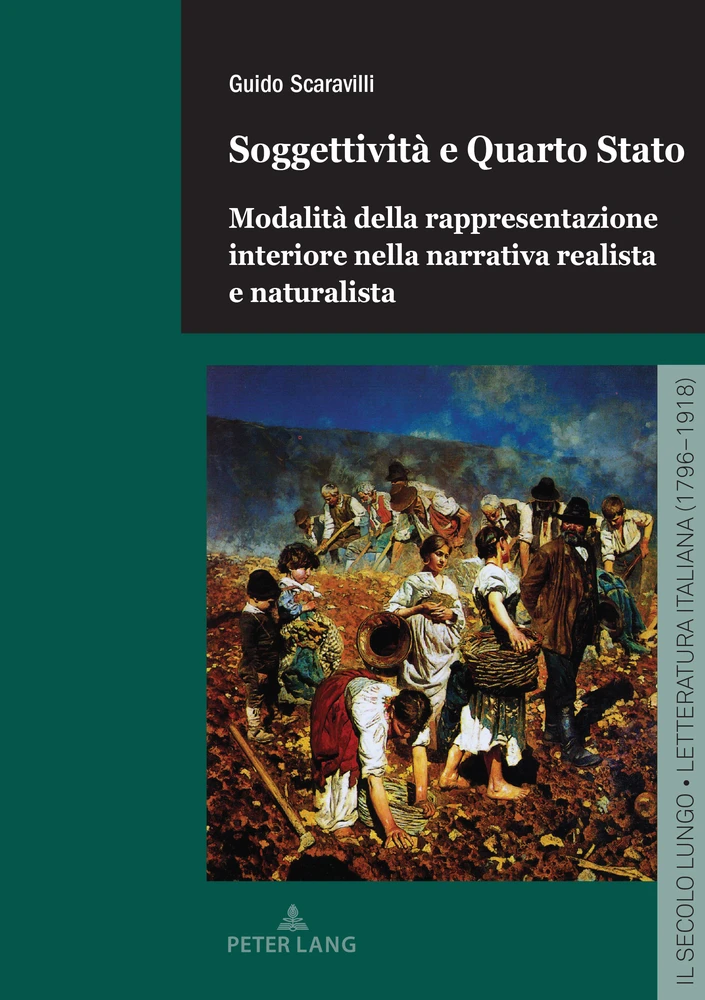Soggettività e Quarto Stato
Modalità della rappresentazione interiore nella narrativa realista e naturalista
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Copertina
- Titolo
- Copyright
- Sull’autore/Sul curatore
- Sul libro
- Questa edizione in formato eBook può essere citata
- Sommario
- Premesse teoriche
- 1. Soggettività e personaggio: per una narratologia oltre Genette
- 2. Narratologia e storia: il sistema stanzeliano
- 3. Situazioni narrative, soggettività e Quarto Stato: una storia possibile
- 4. Avvertenza e ringraziamenti
- 5. Abbreviazioni
- Contaminazioni e interferenze: forme della soggettivazione ne «I promessi sposi»
- 1. Per un attraversamento narratologico de «I promessi sposi»
- 1.1 Prospettiva
- 1.1.1 La situazione narrativa autoriale
- 1.1.2 Concessioni
- 1.1.3 Espropriazioni
- 1.2 La soggettività
- 1.2.1 La psiconarrazione
- 1.2.1.1 Distanza
- 1.2.1.2 Psiconarrazioni e percezioni
- 1.2.1.3 Incubi
- 1.2.1.4 Contagio
- 1.2.2 Il monologo citato
- 1.2.2.1 Ironia
- 1.2.2.2 Pathos
- 1.2.3 Il Monologo narrato
- 1.2.4 Combinazioni
- 2. La psicologia esteriorizzata e i personaggi storici
- 3. Gli umili
- Forme della soggettività umile. Balzac e Sand nel racconto campagnolo europeo
- 1. Il racconto campagnolo europeo
- 1.1 La Francia
- 2. Un privilegio negato: contadini e soggettività nella «Comédie Humaine»
- 2.1 «Les Chouans»
- 2.2 «Le Médecin de campagne» e «Le Curé de village»
- 2.3 «Les Paysans»
- 3. Effetti d’autore: i compromessi della soggettivazione ne «Les Veillées du chanvreur»
- 3.1 «La Mare au Diable»
- 3.2 «François le champi»
- 3.3 «Les Maîtres sonneurs»
- La letteratura «rusticale»: il personaggio popolare tra autonomia ed eteronomia
- 1. La questione contadina e il Risorgimento
- 2. Letteratura e propaganda: modalità della soggettività umile nella narrativa di Giulio Carcano
- 2.1 «Angiola Maria»
- 2.2 «Selmo e Fiorenza»
- 2.3 «Damiano»
- 3. La soggettività popolare nei racconti di Caterina Percoto
- 3.1 «Lis cidulis»
- 3.2 «Un episodio dell’anno della fame»
- 4. ‘Déclassés’, veglie, picari. I sentieri della soggettivazione nella produzione rusticale di Ippolito Nievo
- 4.1 «Il Conte Pecorajo»
- 4.2 «La nostra famiglia di campagna»
- 4.3 «Il milione del bifolco» e l’io narrante de «Le confessioni»
- Soggettività e Quarto Stato nella narrativa naturalista
- 1. La narratologia dei naturalisti e le classi sociali
- 2. «Germinie Lacerteux»
- 3. Zola e il Quarto Stato
- 3.1 «La Fortune des Rougon»
- 3.2 «L’Assommoir»
- 3.2.1 La parola interiore
- 3.2.2 Gervaise
- 3.2.2.1 Passività percettiva
- 3.2.2.2 Dimensione invisibile: tra simpatia e dissonanza
- 3.2.2.3 Coupeau
- 3.2.2.4 Goujet
- 3.3 «Germinal»
- 3.3.1 Étienne Lantier
- 3.3.2 Maheu
- 3.3.2.1 Touissaint Maheu e il discorso sociale
- 3.3.2.2 Catherine Maheu: tra denuncia e riscatto lirico
- 3.4 «La Terre»
- 3.4.1 La caduta di Fouan e il modello shakespeariano
- 3.4.2 Jean Macquart
- 3.4.3 Françoise
- 3.4.4 Jacqueline Cognet
- Umiltà e soggettivazione nella narrativa verista
- 1. Verga
- 1.1 Il primo Verga verista: «Vita dei campi»
- 1.1.1 «Rosso Malpelo»
- 1.1.2 «Jeli il pastore»
- 1.2 «I Malavoglia»
- 1.2.1 Il mondo degli affetti: Padron’Ntoni e Maruzza
- 1.2.2 Storie di due solitudini. Mena e ‘Ntoni Malavoglia
- 1.3 La degradazione del personaggio nelle «Novelle Rusticane»
- 1.4 «Mastro-don Gesualdo»
- 2. De Roberto
- 2.1 «La Sorte»
- 2.1.1 «Ragazzinaccio»
- 2.2 «Processi verbali»
- 2.3 «I Viceré»
- 2.4 Le novelle di guerra
- 2.4.1 «La posta»
- 3. Capuana
- 3.1 «Le Paesane»
- 3.2 «Scurpiddu»
- 3.3 «Il marchese di Roccaverdina»
- Conclusioni
- Indice dei nomi
Premesse teoriche
I più grandi artisti in ogni campo non sono certo quelli che hanno più spesso sulle labbra le idee generali intorno alla loro arte – quelli che maggiormente abbondano in precetti, apologie, formule, e che possono meglio dirci le ragioni e la filosofia delle cose. Di solito, invece, li riconosciamo dalla loro pratica vigorosa, dalla costanza con cui applicano i loro principî, dalla serenità con cui ci lasciano cercare da soli il loro segreto nell’illustrazione, nell’esempio concreto1.
La massima di Henry James non ha carattere negativo, ma al contrario mette a fuoco un prezioso principio metodologico. Non si tratta cioè della stigmatizzazione dell’autoesegesi e del suo statuto conoscitivo (se così fosse, si svuoterebbe di senso l’impianto architettonico della sua stessa teoria del romanzo), ma di un monito fondamentale per il lettore: l’importanza dell’osservazione diretta della forma, della tecnica narrativa, dell’estetica.
Su tale impostazione si fonda il seguente lavoro, che riserva un’attenzione massimale ai testi. Perché se è vero, come pensava Stevenson, che nessun esercizio è più deprimente di quello che induce a «perlustrare le molle e i congegni meccanici su cui si basa qualsiasi forma artistica», allora ogni approccio formalistico sarebbe inesorabilmente condannato in partenza2. L’idea invece da cui prende vita tale trattazione è che la conoscenza delle «molle» e dei «congegni meccanici» non distrugga ma incrementi il «piacere della lettura». Esse consentono di scoprire come sono fatte (secondo quali espedienti, quali sotterfugi, quali codici e accorgimenti) le grandi opere, qual è il loro “segreto”. Lo stile, Gustave Flaubert insegna, è lavoro artigianale, procedimento tecnico, capacità di scegliere e concatenare le parole.
Non è certo un caso che la più efficace e la più illuminante teoria letteraria sia nata spesso nelle officine degli scrittori che – giorno per giorno – si sono misurati con una serie di problemi tecnici e di enigmi costruttivi, risolvendoli grazie alla loro consapevolezza artigianale e alla luce della tradizione entro cui hanno lavorato, e di cui in molte occasioni hanno minato consapevolmente i paradigmi. Né stupisce che la nascita della disciplina che comunemente prende il nome di Narratologia venga convenzionalmente ricondotta alle riflessioni di James e dei suoi epigoni, iniziatori della tradizione anglosassone. Ma l’operazione teoretica jamesiana non si cristallizza per partenogenesi. Al contrario, essa germina su un humus fertilissimo, che lo scrittore aveva avuto modo di conoscere nella sua ricca formazione intellettuale3: la Francia di Émile Zola, in cui la teoria estetica degli autori (su cui il romanziere avrebbe a più riprese scritto nella sua prolifica attività critica4) non di rado costituiva preludio e alimento dell’intuizione creativa, talora sollevando molte delle questioni che avrebbero caratterizzato le speculazioni dei più evoluti narratologi contemporanei.
1. Soggettività e personaggio: per una narratologia oltre Genette
1. È fra i tardi anni Sessanta e primi anni Ottanta del Novecento che vengono pubblicati i testi più importanti di Roland Barthes e Gérard Genette, cioè di alcuni degli autori che ancora oggi sono considerati gli antesignani degli studi narratologici sull’intreccio. Come infatti ricorda Seymour Chatman, la distinzione cruciale da operare, preliminare ad ogni approccio al testo narrativo (quantomeno per la narratologia classica), è quella tra “storia” e “discorso”, tra il “che cosa” un testo racconta e il “come” lo racconta. Esistono quindi, per schematizzare la questione in due facili formule, una “narratologia della storia” e una “narratologia del discorso”: per la prima si ricordano i nomi di Henri Bremond, Algirdas Julien Greimas, Tvetan Todorov, che prendono le mosse dalla Morfologia della fiaba di Propp; per la seconda (che si è progressivamente avviata su un percorso parallelo e indipendente), tutta la tradizione anglosassone che si è occupata del “punto di vista”, nonché la tradizione di cultura francese. In effetti non è la fabula che fa sì che un testo narrativo sia tale. Ciò che contraddistingue una narrazione è il suo carattere mediato: l’interposizione della voce di un narratore tra gli eventi della storia e i destinatari.
Sulla presenza e i modi di articolarsi di questa voce – e la dialettica tra il narratore e l’istanza dei personaggi – i narratologi hanno riflettuto distesamente; e conta poco che col tempo i principali presupposti degli studi sul racconto degli anni Sessanta, tempo del fervore dello strutturalismo (a cui la narratologia è di norma associata in maniera riduttiva), siano stati contestati. Sarebbe infatti fuorviante circoscrivere la stagione narratologica a un singolo ventennio, perché tale interesse, in Europa (e oltreoceano), non è mai scemato: soprattutto a partire dalla metà degli anni Novanta molte scuole si sono imposte, propiziando un mutamento di paradigma. In particolare, nel 1999 David Herman ragionava sul fatto che la narratologia stesse passando da una fase strutturalista a una fase postclassica, e precisava che la «postclassical narratology […] contains classical narratology as one of its ‘moments’», essendo caratterizzata da molte ipotesi e metodologie di ricerca eterogenee5. La più nota è quella cognitivista, rappresentata da studi in cui i testi sono esaminati tenendo conto dei concetti elaborati nell’ambito delle scienze della mente, che riportano in auge la figura del lettore, relegata ai margini dalla critica di impostazione strutturalista6.
L’Italia, ostile per tradizione agli studi teorici (e sensibilmente in ritardo nella ricezione di narratologie alternative a quella genettiana), ha seguito le ramificazioni del dibattito solo distrattamente (a causa peraltro dell’assenza della traduzione di alcuni testi fondamentali nella storia della critica novecentesca tout court)7. Ma una prospettiva laica sui nuovi sviluppi della disciplina è fondamentale per chiunque intenda occuparsi della manifestazione della coscienza dei personaggi nella fiction, a cui i narratologi di professione hanno offerto risposte illuminanti, che sarebbe infruttuoso ignorare sulla base di limitanti pregiudizi ideologici8.
2. È noto che l’ascesa del novel portò «la cultura europea a un’attenzione nuova» alla «vita privata»; la proliferazione degli individui nella diegesi (designati con un nome proprio e collocati in uno spazio che li determina) «moltiplica la varietà delle storie personali e delle coscienze che esibiscono il proprio mondo attraverso la scrittura»9. D’altra parte, secondo un diffuso topos critico, di cui Käte Hamburger è stata la più convincente e radicale sostenitrice, l’attenzione alla vita intima è un elemento costitutivo della fiction nel suo complesso: la dimensione narrativa è «l’unico luogo conoscitivo in cui è possibile parlare di persone terze non solo in quanto oggetti ma anche in quanto soggetti», in cui «l’io di una terza persona può essere presentato nella sua soggettività»10.
Se nei generi referenziali e storici, continua Hamburger, la possibilità di accesso diretto alla coscienza altrui (e dunque la possibilità di assumere il punto di vista dell’altro) è preclusa, lo specifico della fiction è la possibilità di rendere trasparente l’interiorità di un eroe romanzesco, permettendo al lettore di partecipare alla soggettività dei personaggi; conseguentemente, la studiosa si spinge alla teorizzazione di un linguaggio distintivo della narrativa di finzione, individuando dei patterns linguistici che sono correlati all’emersione delle menti finzionali11. Sono questi gli assunti più importanti di Die Logik der Dichtung (1957), ed è a tali riflessioni che Dorrit Cohn si rifà in Transparent Minds (1978)12, in cui la comparatista di origini austriache, individuando una lacuna nella teoria genettiana del Discours du récit (1972), prende pionieristicamente in esame, in maniera empirica, le forme testuali volte a restituire i pensieri dei personaggi, distinguendo tra narrazione in prima persona e narrazione in terza persona (ciascuna caratterizzata dalle sue specificità categoriali e mimetiche); approccio in toto formalistico, che tuttavia avrebbe dato involontariamente l’abbrivio, con brillanti intuizioni, alla stagione postclassica, sovente incline alle forzature e alle strumentalizzazioni del suo pensiero13.
Effettivamente, in Transparents Minds non viene elaborata una compiuta teoria sul personaggio, autentica crux teorica – e luogo di molti equivoci e «confusioni», a dire dello stesso Todorov14 – nella poetica degli strutturalisti, propensi a ridurre questa istanza, in maniera più o meno netta, a una funzione dell’intreccio (a causa anche del loro impegno per un’ideologia che decentra l’uomo e va contro la nozione di individualità e profondità psicologica)15. Del resto anche Genette sembra appartenere a questa schiera con la radicalità della posizione. È sufficiente pensare al Nouveau discours du récit, in cui il critico, dopo aver definito il personaggio uno «pseudo-oggetto», un «“essere vivente senza viscere”»16, un «effetto testuale» costituito da un insieme di segni e strutture linguistiche – e aver avallato l’idea aristotelica secondo la quale l’essenziale del racconto risiede nelle azioni –, si pronuncia così sulla «caratterizzazione», aspetto dell’intreccio che aveva tralasciato (come gli aveva rimproverato Shlomith Rimmon-Kenan in un denso articolo del 1976) in Discours du récit17:
Osservo d’altronde che Shlomith Rimmon[-Kenan] stessa, dopo aver consacrato al personaggio come oggetto un capitolo piuttosto interrogativo (Story: characters), deve poi tornare sull’argomento un po’ dopo, e in modo questa volta più deciso, trattando del discorso (Text: characterization). La caratterizzazione è evidentemente proprio la tecnica di costituzione del personaggio da parte del testo narrativo. Il suo studio mi pare la più grande concessione che la narratologia, almeno in senso stretto, possa fare alla considerazione del personaggio. Ma non rimpiango di averla respinta, o meglio di non averci neppure pensato, nella mia prospettiva: infatti essa mi pareva dar troppo spazio a un semplice «effetto» fra tanti altri, concedendogli il privilegio di avere ritagliato uno spazio a parte, e quindi di guidare l’analisi del discorso narrativo. Trovo decisamente, anche se relativamente, preferibile (più «narratologico») dissolvere lo studio della «caratterizzazione» in quello dei suoi mezzi costitutivi (che non sono tutti specificamente suoi): nominazione, descrizione, focalizzazione, racconto di parole e/o di pensieri, relazione con l’istanza narrativa, ecc18.
Per Genette (che in queste pagine sposa implicitamente la teoria attanziale), non essersi soffermato sulla «caratterizzazione» non è motivo di rimpianto. Nella sua ottica non si tratta di un’«omissione»; piuttosto, una maggiore attenzione al tema sarebbe stata «concessione» eccessiva. Alla disamina organica proposta da Rimmon-Kenan in Narrative Fiction, trova preferibile un’ipotesi di lavoro minore: «dissolvere lo studio della “caratterizzazione” in quello dei suoi mezzi costitutivi». Il personaggio viene così ridotto a un oggetto assolutamente ipotetico, da posporre all’analisi dei procedimenti del «discorso costituente», nell’ambito dei quali gli sarà negato non solo un ruolo di primo piano, ma anche il «privilegio di aver ritagliato uno spazio a parte».
È chiaro che con una simile impostazione – stupefacente se si ricorda che l’impianto del Discours du récit viene concepito sulla base dell’analisi de La Recherche du temps perdu (laddove Marcel non è evidentemente la somma totale delle sue azioni, quanto piuttosto l’insieme dei suoi ricordi) – la soggettività non può che essere considerata un effetto collaterale dei vettori del racconto. Invece, per Cohn i personaggi non sono degli pseudo-oggetti, ma dei soggetti dotati di tridimensionalità19. Non che per lei la loro psicologia non sia fittizia come ogni altra componente della fiction; tuttavia, essa non può essere ridotta a una funzione. Non per nulla la narratologa teorizza la necessità di trattare separatamente i discorsi dei personaggi dai loro pensieri: nella mente non ci sono solo parole, esiste una «non-verbal dimension of cousciousness»20; anche le coscienze d’invenzione sono abitate, oltre che da discorsi, da emozioni, sentimenti, visioni…21
È un punto cruciale. Per Genette la distinzione tra discorsi e pensieri è superflua. Lo si evince nel Nouveau discours du récit, in cui il narratologo, confutando le obiezioni mosse al suo sistema dai contemporanei, dopo essersi espresso favorevolmente su Transparent Minds (interpretato, forse imperialisticamente, come un’utile integrazione alla tassonomia del Discours du récit)22, replica in maniera piccata alle critiche della studiosa. Nello specifico, egli sostiene che «il racconto conosce solo avvenimenti oppure discorsi», che la vita psichica dei personaggi «può essere solo o l’uno o l’altro»23, che della soggettività, se si tolgono le azioni, gli avvenimenti e i discorsi, non resta nulla: da qui, con tutta probabilità, le ragioni della non adeguata collocazione e rappresentazione dell’indiretto libero nel suo sistema. Il disaccordo di Genette da Hamburger e da Cohn (entrambe prosecutrici, a suo giudizio, di una linea formalista), più che su «nuances de detail» – come aveva affermato, minimizzando con disinvoltura, in un’intervista del 2010 inclusa nel suo ultimo libro, Postscript – verte insomma su una questione essenziale per la genealogia del romanzo contemporaneo, perché le due studiose muovono da un principio teorico incompatibile con la concezione strutturalista del personaggio: l’idea hamburgeriana che l’accesso all’interiorità dei personaggi sia un carattere distintivo della finzione narrativa24.
2. Narratologia e storia: il sistema stanzeliano
1. A Genette non era presumibilmente sfuggita la «surprising underestimation», da parte di Cohn, della griglia analitica del Discours du récit25: soprattutto per i racconti in terza persona, la studiosa riprende la terminologia di Franz Karl Stanzel, con cui anche Genette discute a lungo in Nouveau discours du récit.
Stanzel e Cohn convergevano specialmente nella concezione del personaggio, al quale il primo aveva conferito un rilievo inedito nella sua complessa teoria, concepita nel 1955 in Die typischen Erzählsituationen im Roman e poi variamente rielaborata fino alla pubblicazione di Theorie des Erzählens, del 1979, e alla traduzione in inglese, revisionata dall’autore, del 1984 (A Theory of Narrative)26. Questa teoria si impernia sul concetto di mediacy, termine che designa l’atto o la facoltà di un’istanza narrativa di mediare un contenuto finzionale. Per determinare come la mediacy agisca in un testo, è necessario, per Stanzel, intrecciare tre parametri (la persona, il modo e la prospettiva), dalla combinazione organica dei quali discendono le tre situazioni narrative, forme idealtipiche di racconto a cui può essere ricondotta la maggior parte dei testi narrativi. Esse sono: la situazione narrativa in prima persona, dove il narratore è un personaggio della storia; la situazione narrativa autoriale (che corrisponde alla categoria genettiana di onniscienza)27, che s’incentra su un teller-character: il lettore ha l’impressione di una voce, di qualcuno che gli parla e gli spiega un mondo e gli racconta una storia, guidandolo con mano sicura nell’avventura; la situazione narrativa figurale – quella che qui più interessa – che si realizza quando il narratore dissimula la sua presenza, affidandosi alla sensibilità di un personaggio riflettore, attraverso la cui prospettiva i contenuti vengono filtrati28.
Non è solo dunque il narratore ad avere la facoltà di mediare un racconto: anche al soggetto finzionale può essere concesso un simile privilegio. E con questo personaggio il lettore può simpatizzare, provando un’esperienza diretta degli eventi narrati, come se il racconto si facesse da sé: «It is a genre-specific feauture of narrative that the presentation of the consciousness can create the illusion of immediacy»; «Interior monologue, free indirect style and figural narrative situation […] suggests immediacy, that is, the illusion of direct insight into the character’s thoughts; «Presentation of consciousness and inside view are effective means of controlling the reader’s sympathy […]. The more a reader learns about the innermost motives for the behaviour of a characther the more inclined he tends to feel understanding, forbearance, tolerance, and so on, in respect to the conduct of this character»29.
La sintonia tra Cohn e Stanzel è evidente: per entrambi il personaggio, quantomeno nei romanzi o nei racconti più significativi della modernità, non è solo un elemento di raccordo tra le componenti dell’intreccio, ma un’istanza fondamentale, senza la quale le dinamiche profonde della narrativa non potrebbero intendersi30. È attraverso la soggettività di un personaggio che si “vivono” gli eventi e si dà un senso alla storia; è simpatizzando col suo universo psicologico e morale che il lettore può orientarsi nel mondo finto nel testo – ciò che Doležel ha definito storyworld31.
2. Come gli accade quando si misura con Cohn (la cui teoria divergerebbe dalla sua solo per aspetti secondari o terminologici), Genette non sembra cogliere la portata alternativa della proposta dell’altro autore di cui riconosce il valore32. Trova un’unica vera differenza tra il proprio metodo e quello di Stanzel: mentre Discours du récit è animato da uno spirito «analitico» (rivendicato con fierezza), che tende a distinguere le categorie piuttosto che a ibridarle, il metodo di A Theory of Narrative è definito, in maniera velatamente riduttiva, «sintetico»33. Per Genette le «situazioni narrative» nascono dall’«intuizione globale di un certo numero di fatti complessi» – «osservazione empirica» in sé «incontestabile» – in seguito alla quale, però, l’analisi delle specificità diegetiche (cioè l’ésprit de géometrie di marca genettiana, s’intende) è comunque necessaria34. Ciò che invece Genette oscura dell’operazione stanzeliana è la messa a punto di un sistema in cui l’abbandonarsi del lettore alla sensibilità del personaggio gioca un ruolo centrale. Ma è proprio tale abbandono che Genette, anche per una forma di resistenza viscerale, un’insensibilità al fascino delle finzioni narrative tout court (come ho argomentato altrove), non è disposto a concedere35.
Non solo: col definire «sintetico» l’approccio stanzeliano, il critico francese strategicamente sorvola su uno dei maggiori pregi della sua teoria del racconto, la versatilità. Accanto alla situazione narrativa in prima persona, l’autoriale e la figurale – cioè le invarianti del racconto, sistemate nel celebre cerchio tipologico delle forme narrative (il Typenkreis) – Stanzel contempla infatti delle possibilità intermedie e delle anomalie. Il narratologo precisa che la coerenza oltranzista, da parte di un autore, nel realizzare un tipo puro senza alcuna infrazione, è di difficile rinvenimento non solo nel caso dei racconti personali: egli considera le variazioni come un elemento costitutivo della narratività, e l’avvicendamento delle modalità diegetiche un arricchimento dell’opera, che è generalmente difficile da ricondurre a una singola categoria lungo tutta la sua estensione; concezione ‘olistica’ molto efficace per l’interpretazione della narrativa ottocentesca, e in particolare per la produzione realista e naturalista (oggetto della seguente trattazione), giacché essa si impernia su tali variazioni, che il lettore è chiamato a riconoscere e decodificare.
Ma è forse «la capacità di cogliere lo stretto legame che intercorre tra le forme ideal-tipiche» – le situazioni narrative, appunto – «e i testi che nel concreto le realizzano il principale motivo di interesse della teoria del racconto proposta da Stanzel»36. In un pezzo pubblicato recentemente, Giovanni Maffei nota che il «mirifico rosone» stanzeliano, come Genette ironizza in Nouveau discours du récit («l’incastro di assi, di frontiere, di mozzi, di raggi, di punti cardinali, di cerchi e di involucri»)37, «è stato un tentativo generoso di mettere lo spirito schematico dello strutturalismo al servizio della diacronia»38, ovvero di conciliare Poetica e storia, per citare il titolo di un importante saggio incluso in Figures III; invito a una convergenza virtuosa tra i due saperi cui tuttavia l’opera di Genette, al contrario del narratologo austriaco (e in parte di Monika Fludernik, non per caso allieva stanzeliana) mai avrebbe dato effettivamente attuazione39.
Al di là del fatto che A Theory of Narrative, ricco di dettagli analitici e osservazioni particolari, inviti implicitamente a una «storia delle forme considerate come parti di insiemi organici, o per dirla altrimenti a una storia morfologica»40, è infatti possibile notare che il cerchio tipologico è animato da una pulsione diacronica; il Typenkreis mostra come certi tipi ideali siano stati attualizzati nel corso del tempo, e come alcune porzioni si siano “riempite” solo con il procedere della storia della letteratura: la storia sintetica di un genere, e dei confini di volta in volta da esso attraversati41. La cognizione più importante che se ne ricava è che in Italia, come nelle altre letterature europee, a un tipo dominante ne è subentrato un altro (Stanzel li chiama prototipi); alla situazione narrativa autoriale, pervasiva nella prima metà del XIX secolo, è subentrata l’altra specie della situazione narrativa figurale; e corollario di tale transizione è l’inward turn della narrativa, ovvero la svolta interiore, nell’accezione che ne dà Erich Kahler42: la parte essenziale del racconto non si consuma più nel segmento di realtà che tutti possono vedere e udire, «ma si trasferisce nella sfera inapparente che l’eroe e gli eroi custodiscono come un territorio nascosto, come la loro intimità»43. Adoperando il lessico stanzeliano, si può pertanto affermare che l’accesso all’interiorità di un narratore intrusivo lascia spazio ad una rappresentazione diretta delle menti dei personaggi, rese opportunamente trasparenti con la riflettorizzazione44.
Si è soliti associare tale rivoluzione alla stagione modernista; ma si dimentica spesso che il superamento dell’‘autorialità’ si verifica già nel secondo Ottocento: Flaubert per primo decide di rinunciare ad un narratore che accompagni per mano il lettore nello storyworld. Da Madame Bovary (1857) in poi, l’autore sempre più spesso si occulta nel retroscena del testo, affidando a una soggettività diversa dalla sua il compito di mediare al lettore i sensi del racconto. Il mondo esibito dal testo è il mondo quale appare a tale personaggio, osservato dal suo punto di vista, tinteggiato dalle sue emozioni: molti ritrovati di stile sono adoperati dall’autore a rendere queste percezioni, la realtà quale si riflette nello sguardo di questo terzo, da Stanzel appunto definito riflettore. Ma tale processo di transizione è nei fatti più sfumato; tracciare una netta linea di demarcazione tra le due polarità è complesso: non è infrequente che testi spiccatamente ‘autoriali’ (anteriori alla pubblicazione di Madame Bovary) contengano momenti – ancorché imperfettamente – figuralizzati, o quantomeno ‘prospettivizzati’, in cui il narratore rinuncia ai suoi privilegi, assecondando l’ottica del personaggio e dando corpo alle sue sensazioni.
3. Situazioni narrative, soggettività e Quarto Stato: una storia possibile
According to Max Weber, it is the essence of the ideal type that it remains an abstraction which can never be realized by an actual work […]. The recalcitrance of the work in part or as a whole to fit conveniently into a category is as much one of its essential features as conceptual consistency and comprehensiveness are essential features of the ideal type.
[…] Deviation from the ideal type of a narrative situation generally occurs unconsciously, since the author as a rule is not familiar with the system of the typical narrative situations. Deviation from the prototype, however, may be interpreted as the conscious reaction of the author to the most common narrative model in popular literature45.
1. Sono le parole di Stanzel, che, rifacendosi alle riflessioni weberiane (alla base del suo impianto narratologico tripartito), solleva una questione capitale: a differenza della deviazione autoriale dall’ideal-tipo (consustanziale alla sua operazione teoretica, che presuppone norme implicite del medium narrativo di cui gli scrittori sono inconsapevoli), il distanziamento dal prototipo – ovvero dalla situazione narrativa dominante nel momento storico nel quale un’opera s’inscrive – è di norma intenzionale, e contraddice l’«orizzonte di attesa» del lettore. Conseguentemente, diviene per il narratologo imprescindibile, ragionando sulla nozione di «point of view» (e sulla dialettica tra modo e voce, tra chi vede e chi parla, nei termini genettiani), il recupero della teoria formalistica dello straniamento:
Shklovsky’s definition that “art exists that one may recover the sensation of life; it exists to make one feel things, to make the stone stony” can most easily be met by transferring the point of view from “a speaker of the narration words” to a “knower of the narrative story,” from the report of a narrator to the perception experienced by a fictional character. The estranging effect of the experience of unfamiliar perceptions […] can be attained by concentrating on the point of view of characters from the fringes of society. The number of outsiders, of outcasts and declassés who are entrusted with this function in the modern novel […] is an extreme form of the tendency toward estrangement. In all these cases it is precisely the complete shift of the point of view into an outsider which produces the estrangement by causing the reader to see a reality which is familiar to him with entirely “other” eyes46.
Si comprende perché la transizione dalla situazione narrativa autoriale a quella figurale sia marcata. Ciò non solo nei momenti (pure semioticamente centrali) in cui un outsider o un déclassé osserva un universo sconosciuto attraverso le sue percezioni sensoriali, ma anche quando viene data espressione alla dimensione invisibile del personaggio: pensieri, monologhi etc… Un assunto prezioso per ogni atto interpretativo che intenda coniugare il dato formale alla ricerca del significato. Perché con l’emersione di un reflector-character (similmente alla situazione narrativa in prima persona) il lettore è affidato al personaggio47. Sembra che entrambi, lettore e personaggio, «abbiano lo stesso problema: dare un senso all’avventura, guadagnarsi con qualche spesa questo senso, un senso che niente garantisce, un senso […] che nessuno conosceva prima che il racconto cominciasse»48.
2. Ricerca del senso e centralità del personaggio, genealogie formali e infrazioni al paradigma dominante. Tenendo a mente tali presupposti – l’idea di coniugare una prospettiva di lunga durata e il testo considerato nella sua irriducibile singolarità (che dei prototipi storici costituisce esempio di una sintomatica deviazione) – è possibile sviluppare il tema cardinale della trattazione: l’analisi delle modalità della rappresentazione della soggettività del Quarto Stato nella narrativa realista e naturalista; aspetto che necessita di essere inquadrato nell’evoluzione del romanzo moderno nel suo complesso, nell’ambito della quale la mimesi del popolo (non solo della sua psicologia) è epifenomeno della vocazione sociologica – e della tensione totalizzante – del romanzo ottocentesco.
Nel corso dell’Ottocento, infatti, le strutture di senso millenarie del romanzo si dissolvono; si registra «un allargamento enorme del mondo narrabile»49. Tale estensione riguarda la mimesi «di quello che è esteriormente oggettivo nell’accidentalità della sua forma»50: è il racconto del mondo esterno, il Realismo: con l’impulso alla democratizzazione e alla secolarizzazione che deriva dalla Rivoluzione francese, Honoré de Balzac concepisce l’ambizioso proposito di dipingere, nel progetto de La Comédie humaine, la società in tutte le sue componenti: occorreva annettere nel dominio del romanzo ogni classe, ogni carattere, ogni costume della Francia contemporanea. Materia narrativa privilegiata non sono più «gli eroi dell’epos o del romance serio» (vicende straordinarie di uomini fuori dal comune) o «gli uomini di condizione disperata che subiscono i rivolgimenti della sorte» (gli eroi del romance comico, come i picari), ma la «middle station of life», la «medietas della condizione sociale borghese», le scene di vita quotidiana51; e il raggio d’azione viene presto esteso, con modalità differenti a seconda dei casi, al Quarto Stato, ai proletari dell’universo rurale e cittadino: al «monde sous un monde», alla «canaille» (come l’avrebbero spregiativamente definito Edmond et Jules de Goncourt), un ceto sconosciuto, la cui emersione silenziosa destava nelle alte sfere interrogativi e perplessità (e più frequentemente sgomento), ma non poteva essere ignorato da chi ambiva a dipingere la totalità della vita. L’incontro e la scoperta dell’altro; la nascita dell’impegno sociale. Il rapporto con il popolo (in Italia e in Europa) diventa per molti «scelta ideologica», «e comporta una nozione precisa e consapevole dei compiti assegnati allo scrittore nel quadro di un ceto dirigente nazionale»52.
Da tale rivoluzione epistemologica scaturiscono dei corollari estetici e ideologici. Più in particolare, le novità decisive (e generalissime) che si affermano nella narrativa realista all’inizio dell’Ottocento sono tre. Innanziututto la centralità del «paradigma ambientale»53: le azioni e i pensieri dei personaggi sono determinati dal milieu (storicamente e geograficamente dettagliato); in secondo luogo, si afferma la polifonia narrativa. Nel racconto fanno irruzione e si intrecciano voci discordanti; i valori si relativizzano. Infine, e soprattutto, la mescolanza e la contaminazione degli stili. Nella filosofia della storia letteraria che Erich Auerbach propone in Mimesis, la narrativa del XIX secolo si presenta come una forma che distrugge le gerarchie fra le classi, i tipi di azione, gli stili, e rende possibile narrare in modo serio la vita ordinaria delle persone comuni. Cose notissime.
Meno ovvio è un aspetto secondario del problema, su cui non mi pare sia stata gettata luce dalla critica (quantomeno sistematicamente): la possibilità della rappresentazione «seria» della coscienza popolare. Tale interrogativo si pone nella sua urgenza se si considera la produzione naturalista e di fine secolo tout court. Da uno sguardo d’insieme, sembra infatti che in essa la delega narrativa (la mediacy) si presti a una lettura politica. Era quasi canonico che alla soggettività – all’‘anima’ – avessero diritto i nobili e i ricchi; al massimo, diversamente modulata, i piccoli borghesi. Alle «passioni del Quarto Stato si riservava invece tendenzialmente il ghetto dell’osservazione in vitro, dall’esterno, comportamentista», o «un’irriflessa e discontinua psicologia delle masse; tutt’al più una delega non troppo sul serio, a una soggettività centrale ma solo idillica o comica, a rinnovo e perpetuazione dell’aurebachiana separazione degli stili»54. Singolarmente, solo in pochi si sono mossi sulle tracce dei punti di discontinuità di questo sistema, né tantomeno esistono studi che affrontino la questione da un’ottica diacronica: partendo dagli albori del realismo ottocentesco (italiano e francese) per approdare all’esperienza verghiana e zoliana. Mi è parso proficuo tentare, con un percorso scandito in tappe distinte.
La prima parte del volume è dedicata a I promessi sposi: l’atto fondativo, nella letteratura italiana, della rappresentazione romanzesca degli umili. È infatti noto che la scelta manzoniana di incentrare il plot su due contadini ebbe un grande effetto di rottura con le convenzioni letterarie ottocentesche. Sicché non stupisce che l’accesso alla dimensione interiore costituisca un aspetto primario nell’economia del romanzo, nel quale essa è attributo di personaggi eterogenei, e tutt’altro che interdetta agli umili protagonisti: scelta dalla portata rivoluzionaria, solo in parte attenuata dalla proiezione della vicenda in un passato lontano e dimenticato.
La seconda area monografica, divisa in due sezioni, è dedicata alla narrativa campagnola italiana e francese, alla quale i nostri scrittori si ispirarono quanto a modelli tematici e strategie espressive. Dopo una ricostruzione storico-critica del racconto campagnolo europeo, è stato effettuato un approfondimento sulle modalità della rappresentazione interiore nella produzione campestre di Balzac e George Sand: scrittori che furono interpreti, in maniera profondamente diversa, di tale stagione letteraria. Mentre la seconda sezione è occupata dalla narrativa «rusticale», che si diffuse nel Lombardo-Veneto durante la lunga vigilia del «decennio di preparazione», in cui si faceva urgente, perché subordinata al fine dell’unificazione politica, il problema della riforma dei rapporti sociali delle campagne; tematica su cui anche Giulio Carcano e Caterina Percoto – nei loro racconti campagnoli – come Ippolito Nievo (nella produzione rusticale e tangenzialmente ne Le confessioni d’un italiano) si espressero attraverso il dispositivo letterario.
L’ultima area monografica prende in esame la narrativa naturalista e verista. Dopo un attraversamento della teoresi dei naturalisti, che nelle loro prefazioni ragionarono, con un’inedita attenzione sociologica, sulla possibilità della rappresentazione interiore, è stata proposta una disamina di alcuni testi francesi reputati tipicamente rappresentativi quanto alla soggettività del Quarto Stato: da Germinie Lacerteux ai romanzi zoliani sul popolo. Nell’ultima sezione viene infine condotta una ricognizione della narrativa di Giovanni Verga, Luigi Capuana e Federico De Roberto; un percorso che prende l’abbrivio dai prodromi dell’esperienza verista per approdare al Marchese di Roccaverdina (1901) e alle novecentesche novelle belliche di De Roberto, in cui l’autore nuovamente si lanciò, con maggiore spregiudicatezza espressiva, a rappresentare la diversità sociale delle psicologie e la pluralità degli antagonismi sociali, ma su un nuovo (promettentissimo) sfondo narrativo.
4. Avvertenza e ringraziamenti
Questo libro rielabora la mia tesi di dottorato, discussa nel 2023 alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Alcuni paragrafi riducono o fondono tra di loro, rimaneggiandoli in maniera sostanziale, saggi già apparsi in volume o in rivista dal 2017 in poi. Ne riporto di seguito gli estremi bibliografici: La narratologia dei naturalisti e le classi sociali, in «Status Quaestionis», 12, 2017, pp. 176-209; Genette e il personaggio, in S. Ballerio e F. Pennacchio (a cura di), Il conoscibile nel cuore del mistero, Milano, Ledizioni, 2020, pp. 99-120; Strategie narrative e rappresentazione della soggettività in «Jeli il pastore», in C.M. Pagliuca, F. Pennacchio (a cura di), Narratologie. Prospettive di ricerca, Atti del seminario permanente di narratologia, Napoli, 20-21 ottobre 2020, Biblion, Napoli, 2021, pp. 203-226; Due umili verghiani. Strategie della soggettivazione in «Rosso Malpelo» e «Jeli il pastore», in «Status Quaestionis», n. 24, 2023; «Una specie di smarrimento»: soggettività e Quarto Stato ne «Il Mastro-don Gesualdo» e «Il Marchese di Roccaverdina», in «Esperienze letterarie», Anno XLVIII/2, 2024, pp. 42-84; De Roberto e il Quarto Stato: i compromessi della soggettivazione da «La Sorte» a «I Viceré», in «Italianistica», LVIII, n. 1, 2024, pp. 97-113.
Desidero ringraziare Claudio Gigante, correlatore della mia tesi, per avermi incoraggiato a continuare il lavoro nonostante le difficoltà, e per avermi ospitato nella sua collana (codiretta con il professor Dirk Vanden Berghe, che ha accettato di buon grado la proposta e mi ha subito mostrato la sua disponibilità); ringrazio inoltre il professore Giovanni Maffei (il mio maestro), a cui devo molte delle idee di questo libro, e Pierluigi Pellini, dispensatore di consigli preziosi. Un grazie speciale va infine alla mia famiglia, a cui il libro è dedicato, che mi ha confortato nei momenti più bui e che mi ha offerto un supporto indispensabile senza il quale questa monografia non avrebbe potuto vedere la luce.
5. Abbreviazioni
Le opere di alcuni autori sono citate in modo abbreviato con le seguenti sigle:
- PS = A. Manzoni, I promessi sposi, a cura di E. Raimondi e L. Bottoni, Milano, Principato, 1987.
- CH = H. de Balzac, Les Chouans, in La Comédie humaine, a cura di M. Bouteron, vol. 7, Études des mœurs. Scènes de la vie parisienne, Paris, Gallimard, 1950.
- SC = Id., La Comédie humaine, a cura di M. Bouteron, vol. 8, Étuedes des mœurs. Scènes de la vie de campagne, cit.
- MD = G. Sand, La Mare au Diable, in id., Romans, a cura di J.-L. Diaz, vol. 1, Paris, Gallimard, 2019.
- FC = Id., François le champi, in id, Romans, cit.
- AM = G. Carcano, Angiola Maria, Firenze, Le Monnier, 1852.
- NV = Id., Novelle, in Opere Complete, vol. 3, Milano, Cogliati, 1893, p. 362.
- DM = Id., Damiano. Storia di una povera famiglia, vol. 1, Milano, Borroni e Scotti, 1850, p. 54.
- RP = C. Percoto, Racconti, a cura di A. Chemello, Roma, Salerno, 2011.
- CP = I. Nievo, Il conte pecorajo, a cura di S. Casini, Venezia, Marsilio, 2010.
- NC = Id., Il novelliere campagnuolo, a cura di I. De Luca, Torino, Einaudi, 1956.
- GL = E. et J. de Goncourt, Œuvres complètes, Œuvres romanesques a cura di A. Montandon, t. IV: Germinie Lacerteux, edizione critica a cura di S. Thorel-Cailleteau, Paris, Champion, 2011.
- DP = É. Zola, La Fabrique des Rougon-Macquart. Éditions des dossiers préparatoires, a cura di C. Becker, vol. 1, Paris, Champion, 2003.
- FR = Id., La Fortune des Rougon, in Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, a cura di A. Lanoux e H. Mitterand, vol. 1, Paris, Gallimard, 1960.
- AM = Id., L’Assommoir, in Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, vol. 2, cit.
- GM = Id., Germinal, in Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, vol. 3, cit.
- TR = Id., Les Rougon-Macquart. Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le Second Empire, vol. 4, cit.
- TN = G. Verga, Tutte le novelle, a cura di C. Riccardi, Milano, Mondadori, 1979.
- RM = Id., Rosso Malpelo, in Vita dei campi, edizione critica a cura di C. Riccardi, Firenze, Le Monnier, 1987.
- Tr1 = Id., Jeli il pastore, in Vita dei campi, edizione critica a cura di C. Riccardi, cit.
- MV = Id., I Malavoglia, a cura di R. Luperini, Milano, Mondadori, 1988.
- MG = Id., Mastro-don Gesualdo, a cura di G. Mazzacurati, Torino, Einaudi, 1992.
- SR = F. De Roberto, La Sorte, Palermo, Sellerio, 1997.
- PV = Id., Processi verbali, Palermo, Sellerio, 1976.
- VR = Id., I Viceré, a cura di M. Novelli, Milano, Mondadori, 2012.
- NG = Id., «La paura» e altri racconti di guerra, a cura di G. Pedullà, Milano, Garzanti, 2015.
- RC = Racconti. Luigi Capuana, a cura di E. Ghidetti, vol. 2, Roma, Salerno, 1973-1974.
- MV = L. Capuana, Il Marchese di Roccaverdina, Milano, Mondadori, 1991.
1 H. James, Guy de Maupassant, in Id., L’arte del romanzo. Saggi sulla scrittura e ritratti di autori, Milano, PGRECO, 2013, p. 137.
2 R.L. Stevenson, On Some Technical Elements of Style in Literature, in «Contemporary Review», Aprile 1885; tr. it. Alcuni elementi tecnici dello stile nella letteratura, in L’isola del romanzo, a cura di G. Almansi, Palermo, Sellerio, 1987, p. 179. Le opere narratologiche saranno sempre citate col titolo in lingua originale. Quanto alle citazioni, esse verranno riportate in italiano facendo riferimento alla traduzione corrispondente; in caso di assenza di una traduzione italiana, la citazione verrà riportata in lingua originale.
Details
- Pages
- 422
- ISBN (PDF)
- 9783034351119
- ISBN (ePUB)
- 9783034351126
- ISBN (Softcover)
- 9783034351102
- DOI
- 10.3726/b22081
- Language
- Italian
- Publication date
- 2024 (November)
- Keywords
- Subjectivity Fourth Estate Narratology
- Published
- Bruxelles, Berlin, Chennai, Lausanne, New York, Oxford, 2024. 422 pp.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG