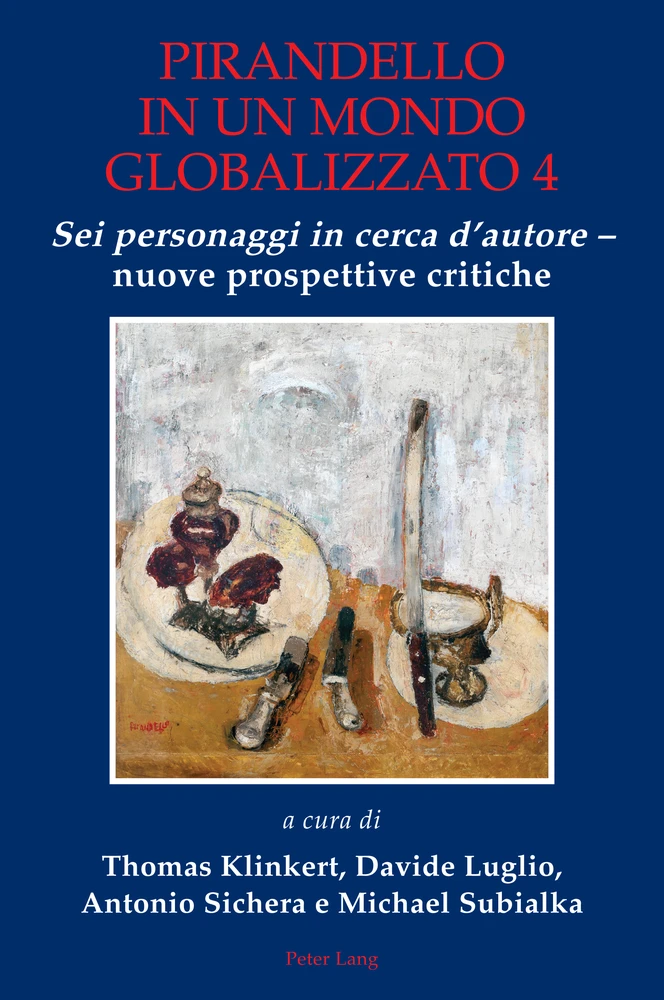Pirandello in un mondo globalizzato 4
«Sei personaggi in cerca d’autore» – nuove prospettive critiche
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Copertina
- Titolo
- Copyright
- Sull’autore/Sul curatore
- Sul libro
- Questa edizione in formato eBook può essere citata
- Indice
- Tavola delle abbreviazioni
- Introduzione. Sei personaggi in cerca d’autore – nuove prospettive critiche
- I. La questione del genere: i Sei personaggi tra novella, commedia e tragedia
- La tragedia dei personaggi in cerca d’autore. Dalle novelle al dramma: varianti e rielaborazioni
- La trama proibita dei Sei personaggi – Spettacolo dell’impossibilità del dramma, addio alla mimesis o allegoria neo-barocca?
- Sei personaggi in cerca d’autore, ovvero la tragedia impossibile
- II. La dimensione transmediale: teatro, cinema, musica
- Il regista Stéphane Braunschweig, traduttore/creatore di Sei personaggi in cerca d’autore
- Ancora sui trattamenti cinematografici dei Sei personaggi
- I due Fratelli Taviani e i Sei personaggi
- Padre e Figliastra. Duetto da fare
- III. La dimensione della psicopatologia e dell’inconscio
- «Mi sa dire chi è Lei?» – Trasformazioni del discorso psichiatrico di Les altérations de la personnalité di Alfred Binet nella Prefazione ai Sei personaggi in cerca d’autore
- Fatalità della finzione e finzioni fatali: la realtà del delirio nei Sei personaggi in cerca d’autore e nei Quaderni di Serafino Gubbio operatore
- «Il mistero della creazione artistica». Numerologia, occultismo e psicopatologia nei Sei personaggi in cerca d’autore
- Grovigli d’autore e senno di poi. No te sulla Prefazione ai Sei personaggi
- La detronizzazione del padre
- IV. Predecessori e posterità: la posizione dei Sei personaggi nella storia letteraria
- Sei personaggi in cerca d’autore come scardinamento del teatro attraverso il metateatro
- Verga e Pirandello: «Senza autore»
- Oltre il modello pirandelliano? I personaggi autonomi nella letteratura spagnola degli anni Venti e Trenta
- V. La dimensione epistemologica dei Sei personaggi
- Sei personaggi in cerca di un significato universale
- Fenomenologia pirandelliana: tra realtà e fantasia
- La teologia dei Sei personaggi 1921
- Sugli autori
- Indice dei nomi
- Indice delle opere di Pirandello
Tavola delle abbreviazioni
Per rimandare ai testi di Pirandello si usano, per comodità di chi legge, le sigle introdotte nei volumi dell’Opera Omnia pubblicati nella collana «I Meridiani» dall’editore Mondadori.
Thomas Klinkert, Davide Luglio, Antonio Sichera, Michael Subialka
Introduzione. Sei personaggi in cerca d’autore – nuove prospettive critiche
Sembra difficile per uno studioso di letteratura dire su Pirandello qualcosa che lui non abbia già detto, distanziarsi adeguatamente cioè dalla sua poetica acuta e intrusiva. Le sue riflessioni teoriche si trovano sia nei testi che nei paratesti, come la Prefazione ai Sei personaggi, pubblicata originariamente con il titolo «Come e perché ho scritto i ‘Sei personaggi in cerca d’autore’» il 1° gennaio 1925 sulla rivista Co- moedia (MNII, 653–67). Questa Prefazione articola chiaramente l’idea di base del metateatro di Pirandello. Com’è noto, Pirandello riferisce come la sua «servetta», chiamata Fantasia, gli avesse portato in casa un giorno i Sei personaggi che gli avevano chiesto di trasformare la loro storia in un romanzo. Non riuscì però a scrivere questo romanzo, perché nella storia dei Sei personaggi mancava qualcosa di fondamentale, cioè «un senso», che avrebbe dato a questa storia un certo valore. Così aveva cercato di sbarazzarsi dei Sei personaggi («[…] facevo di tutto per allontanarli», MNII, 655). Ecco il motivo del conflitto tra l’autore, che si rifiuta di trasformare la storia dei Sei personaggi in un romanzo, e i personaggi stessi, resisi autonomi («[…] seguitavano a vivere per conto loro», MNII, 656) – un assillo costante, una richiesta insistente di rappresentazione. Per sfuggire a questo conflitto, Pirandello decide di scrivere, invece del dramma portato dai Sei personaggi, il dramma che egli stava vivendo con loro, cioè il dramma del rifiuto del dramma da parte dell’autore e il conflitto che ne deriva. In altre parole, Pirandello è passato dal livello dell’oggetto (la rappresentazione di un’azione) a un metalivello (la rappresentazione della rappresentazione di un’azione o più precisamente: la rappresentazione della non rappresentazione di quest’azione). Questa opposizione tra il livello dell’oggetto e il metalivello è il centro strutturale dell’opera di Pirandello.
Che cosa implica esattamente questa opposizione? La rappresentazione di un’azione su un palcoscenico si appoggia su un dispositivo di osservazione: gli spettatori nel teatro osservano le azioni rappresentate sulla scena. Questa osservazione implica un momento di riflessività, perché non si tratta di azioni del mondo reale, ma della rappresentazione di azioni più o meno simili ad azioni che possono aver luogo nel mondo reale. La comunicazione teatrale può quindi solo funzionare se le persone presenti sul palcoscenico, nella loro funzione di attori, fingono di essere qualcun altro, creando così una realtà fittizia. Per citare un esempio: gli attori che si preparano a rappresentare la commedia Il giuoco delle parti, alla cui prova si assiste all’inizio dei Sei personaggi, non sono Leone Gala, sua moglie Silia e Guido Venanzi, ma fingono di esserlo. Questo presupposto fondamentale della finzione teatrale deve essere condiviso dal pubblico. Solo con questa premessa la comunicazione teatrale può aver luogo. Se invece la premessa non è condivisa, la comunicazione teatrale è resa impossibile. Introducendo un metalivello di osservazione dell’osservazione – ossia di osservazione di secondo ordine nel senso di Niklas Luhmann1 – attraverso l’idea di base dei Sei personaggi, Pirandello dà ai suoi spettatori la possibilità di percepire ciò che è tacitamente assunto e indiscusso nella normale comunicazione teatrale. Un esempio di questo è la reazione della Madre quando vede Madama Pace, strappandole la parrucca e gettandola con rabbia sul pavimento, rimproverandola selvaggiamente (MNII, 721). La confusione tra finzione teatrale e realtà vissuta distrugge la mimesis teatrale e rende percepibile agli spettatori di assistere a una mimesis. Possiamo dire che già la normale situazione di comunicazione nel teatro è un’osservazione di secondo ordine, che a sua volta osserva le osservazioni di primo ordine che vengono rappresentate sul palco come parte di una finzione. Che l’osservazione degli attori sulla scena si trasformi nell’osservazione di una finzione presuppone l’accettazione di una convenzione di finzionalità. Questa accettazione è tacita.
Ma quando, come accade nel metateatro di Pirandello, all’osservazione di secondo ordine si sovrappone la meta-osservazione di terzo ordine, le tacite premesse della normale comunicazione teatrale sono esposte. Questa esposizione ha un effetto epistemico esponendo gli eventi normali nella loro artificiosità, o nominando e rendendo visibili i contesti abituali che formano il dispositivo del teatro. Quando i Sei personaggi entrano in scena durante la prova e disturbano il Capocomico e i suoi attori nel loro lavoro, il Capocomico cerca di mandarli via, chiamandoli pazzi. Si sviluppa quindi il seguente dialogo:
il padre (ferito e mellifluo) Oh, signore, lei sa bene che la vita è piena d’infinite assurdità, le quali sfacciatamente non han neppure bisogno di parer verosimili; perché sono vere.
il capocomico Ma che diavolo dice?
il padre Dico che può stimarsi realmente una pazzia, sissignore, sforzarsi di fare il contrario; cioè, di crearne di verosimili, perché pajano vere. Ma mi permetta di farle osservare che, se pazzia è, questa è pur l’unica ragione del loro mestiere. (MNII, 680)
Il Padre diventa qui il portavoce dell’autore Pirandello, che scrive proprio in quell’anno, il 1921, qualcosa di simile in relazione alla storia di Mattia Pascal, la cui presunta assurdità fu superata da una storia vera che lesse sul giornale.2 Nel dialogo tra il Padre e il Capocomico si ridefinisce il rapporto tra vero e verosimile. L’argomento del Padre è che alcuni avvenimenti reali della vita sono così assurdi che è un’espressione di pazzia sforzarsi sulla scena teatrale di creare l’apparenza della verità attraverso la verosimiglianza; la premessa è che la verità non è necessariamente verosimile. Ma questa pazzia, secondo il Padre, è la ragion d’essere della professione di attore. Il confronto metateatrale tra una figura letteraria e un gruppo di professionisti del teatro porta qui a una messa in discussione fondamentale di ciò che gli attori teatrali fanno normalmente. In altre parole, la convenzione della finzione, ciò che Coleridge chiama «willing suspension of disbelief» (sospensione volontaria dell’incredulità), è qui messa in discussione e dichiarata pazzia. La forma di metateatro scelta da Pirandello, che non era mai stata realizzata così fino ad allora, sebbene abbia naturalmente dei precursori, per esempio Shakespeare, Calderón o Corneille, è una forma di straniamento che, nel senso dei formalisti russi, rende possibile un nuovo vedere. Questo nuovo modo di vedere ha, come dice Pirandello stesso nella sua Prefazione, una funzione epistemologica. Lui stesso, come scrive, è uno scrittore filosofico e mira a scoprire un «particolar senso della vita» nei soggetti dei suoi testi letterari. Mettendo in pratica l’idea dei Sei Personaggi, capisce qualcosa; scopre un significato nei Sei Personaggi che prima non gli era chiaro. Questa realizzazione riguarda i seguenti elementi:
[…] l’inganno della comprensione reciproca fondato irrimediabilmente sulla vuota astrazione delle parole; la molteplice personalità d’ognuno secondo tutte le possibilità d’essere che si trovano in ciascuno di noi; e infine il tragico conflitto immanente tra la vita che di continuo si muove e cambia e la forma che la fissa, immutabile. (MNII, 657)
Così Pirandello finisce per ritrovare nella storia dei Sei personaggi quel significato più profondo la cui mancanza lo aveva convinto a rifiutarli. Questa è un’indicazione della qualità epistemica della prospettiva metateatrale. Essa permette che la banalità apparente di un dramma familiare, trattando temi melodrammatici classici come l’inganno, il tradimento, la gelosia, la vergogna e così via, sia considerata in una nuova luce e quindi renda possibile riconoscere connessioni nascoste. Naturalmente, la funzione del metateatro non può essere ridotta a queste intuizioni. Pirandello si preoccupa anche del piacere della provocazione che era caratteristico delle avanguardie del primo Novecento; si preoccupa di rappresentare i conflitti tra l’autore, il regista teatrale, gli attori e le altre persone coinvolte in una produzione (tecnici di scena, suggeritore, ecc.); lascia che il pubblico guardi dietro le quinte delle sue opere, ci mostra il processo di creazione di uno spettacolo e i relativi litigi, equivoci, gelosie, ecc.; così la sua opera diventa anche una rappresentazione satirica del teatro. Nella maniera tipica dell’umorismo, Pirandello include anche se stesso nella propria prospettiva. È, dopo tutto, una commedia della sua penna, Il giuoco delle parti, che gli attori stanno provando quando vengono interrotti dai Sei personaggi. Ad un certo punto, il Capocomico dice:
Che vuole che le faccia io se dalla Francia non ci viene più una buona commedia, e ci siamo ridotti a mettere in iscena commedie di Pirandello, che chi l’intende è bravo, fatte apposta di maniera che né attori né critici né pubblico ne restino mai contenti? (MNII, 676)
Qui Pirandello ci mostra la sua situazione di drammaturgo innovativo, artisticamente esigente, che non è immediatamente compreso dal pubblico e neanche dai praticanti della scena. Le sue opere sono state spesso accusate di essere troppo cerebrali e di presentare problemi poco divertenti. Le reazioni del pubblico alla prima di Sei personaggi sono anche un’indicazione del rifiuto che l’estetica di Pirandello ha incontrato. Molti spettatori se ne andarono indignati o lanciarono addirittura monete contro l’autore.
Fortunatamente, la lunga e fruttuosa storia della ricezione di questo dramma non ha confermato il rifiuto originario di una parte del pubblico. Questo è uno dei presupposti del convegno internazionale tenutosi a Zurigo dal 4 al 6 novembre 2021, dove esperti rinomati e giovani ricercatori si sono scambiati opinioni su vari aspetti rilevanti del testo di Pirandello e della sua estetica, scoprendo nuove prospettive di ricerca.3 Il presente volume raccoglie questi contributi, che verranno ora brevemente presentati, tenendo conto del loro ordine. Questo renderà comprensibile la struttura del volume.
I. La questione del genere: i Sei personaggi tra novella, commedia e tragedia
Il saggio di mareen kahlisch analizza l’evoluzione dell’idea di personaggio ‘autonomo’ prodotto dalla fantasia e in cerca d’autore, ricostruendone la genesi a partire dal nucleo novellistico originario individuato, sebbene parzialmente, in un testo del 1905 intitolato Una novella che non farò. Ma è soltanto un anno dopo, in Personaggi, che si affaccia compiutamente l’idea del personaggio autonomo e la figura della servetta Fantasia ripresa quasi 20 anni più tardi nella Prefazione aggiunta alla quarta edizione dei Sei personaggi del 1925. L’idea viene ulteriormente sviluppata nelle novelle metanarrative La tragedia d’un personaggio del 1911 e Colloquii coi personaggi del 1915. Tuttavia, pur dopo essere approdata nella commedia dei Sei personaggi, rappresentata per la prima volta il 9 maggio 1921, l’idea del personaggio ‘autonomo’ in cerca d’autore, come mostra Mareen Kahlisch, continua ad evolvere sul filo degli adattamenti della commedia acquisendo una sempre maggior concretezza.
Nel suo contributo, michael rössner prende di petto la questione dell’interpretazione complessiva dei Sei personaggi, ponendo una domanda fondamentale. Si tratta di leggere il capolavoro pirandelliano come una dichiarazione dell’impossibilità di poetica della mimesis ovvero, come pensava Peter Szondi, in termini di allegoria neo-barocca della condizione dell’uomo posto di fronte alla morte di Dio? La risposta del critico è netta. Dal suo punto di vista, i Sei personaggi esprimono, da parte di Pirandello, nient’altro che il rifiuto di una trama melodrammatica di incesto ed adulterio, con elementi di critica sociale, secondo la consolidata tradizione del naturalismo teatrale. Per dimostrare la propria tesi Michael Rössner istituisce un insistito parallelismo tra i Sei personaggi e Tutto per bene. Emerge, da questa analisi, il chiaro fallimento del modello realista e di una conseguente interpretazione ‘borghese’ (e dunque storica) del più grande dramma di Pirandello.
Muovendo dall’analisi dell’ultimo allestimento di Sei Personaggi in cerca d’autore, nel 1936 al Teatro Argentina di Roma, il saggio di alfredo sgroi analizza il tentativo pirandelliano di associare la vicenda descritta alla tragedia classica. L’autore sottolinea come Pirandello abbia tentato di recuperare il genere tragico in una società moderna caratterizzata dalla mancanza di antiche concezioni morali e religiose ma contemporaneamente abbia riconosciuto l’impossibilità di riportare il vero dramma tragico sulle scene moderne, data l’opacità ideologica di quei tempi. L’opera diventa così un groviglio di contraddizioni e paradossi che la rendono enigmatica. Alfredo Sgroi analizza l’incapacità dei personaggi dell’opera di compiere atti tragici veri e propri, mettendo in evidenza il contrasto tra la visione borghese e nichilista del mondo moderno e la concezione classica della tragedia, in cui le azioni eroiche e le leggi divine erano centrali. Si evidenzia anche come Pirandello abbia rappresentato la società borghese come superficiale e priva di profondità tragiche, incapace di accogliere la dimensione mitica e catartica del teatro classico. In questo senso, per Alfredo Sgroi, Sei personaggi può essere considerata come un’antitragedia, per la sua incapacità di approdare a una risoluzione definitiva o a una restaurazione dell’ordine.
II. La dimensione transmediale: teatro, cinema, musica
Il contributo di dominique budor esamina il lavoro di un grande regista contemporaneo – Stéphane Braunschweig – sul testo e sulla resa scenica dei Sei personaggi. La scelta forte del regista francese è quella di riscrivere il testo, aggiungendovi prologhi ed interludi, per enfatizzare al massimo la tendenza metateatrale di Pirandello (Six personnages, Les Solitaires Intempestifs, 2012). Il testo viene modernizzato, adattato agli ascoltatori, valorizzato nella sua componente orale. Sul piano dell’interpretazione scenica, l’attore di Braunschweig (chiamato ormai per nome) deve attingere alle proprie risorse fisiche e affettive per una interpretazione adeguata e profonda del personaggio. D’altronde, nella visione del regista francese gli attori sono co-creatori del testo, al fine di mettere in crisi, in maniera quanto più forte possibile, il paradigma dell’unica verità. La revisione del finale dell’opera chiarisce come al centro del mondo di Pirandello, nell’interpretazione di Braunschweig, ci sia in definitiva la morte.
Analizzando i tre testi prodotti da Pirandello nell’intenzione di preparare la produzione di un film basato sui Sei personaggi, film che non è mai stato realizzato durante la vita dell’autore, e constatando che questi tre testi – cioè un Prologo scritto probabilmente nel 1926 e pubblicato nel 1941, la Film-Novelle del 1928 e il Film Treatment del 1935 – hanno in comune che il personaggio del Padre, centrale nella pièce, viene eclissato dall’autore, marina paino interpreta questa sostituzione strutturale molto significativa che modifica un elemento centrale del testo, facendo riferimento alla vita di Pirandello. In effetti, l’autore, come risulta chiaramente dalla sua corrispondenza con Marta Abba, concepiva la riscrittura cinematografica della sua opera più celebre come la preparazione di un lavoro «nato da NOI DUE». Questo desiderio di produrre un’opera unendo l’autore e la sua musa si manifesta nell’idea che il ruolo della Figliastra sia incarnato da Marta Abba, mentre quello dell’autore sia giocato da Pirandello stesso. Nella gestazione del progetto cinematografico si produce addirittura uno scambio di idee tra Marta Abba e Pirandello, che si manifesta per esempio nella scena iniziale dello scenario mostrando una ragazza che si aggira di notte per una strada dove avrà luogo l’incontro con l’autore; è questa scena che la Abba aveva visto in un film, narrandola in una lettera a Pirandello.
Ispirandosi al celebre film Tu ridi dei Fratelli Taviani (1998), il saggio di daniela bini esplora un episodio poco conosciuto, in quanto eliminato dal film, nel quale i registi immaginano due momenti importanti nella vita di Pirandello che riguardano il rapporto conflittuale con la figlia Lietta. Daniela Bini evidenzia così il significato sovradeterminato dell’episodio mancante, mostrando come i registi lo utilizzino da un lato per esplorare la biografia dell’autore e la psicologia della sua arte, e dall’altro per avviare un discorso metanarrativo sulla natura filosofica della creazione artistica e dell’umorismo pirandelliano. Concentrandosi sulla sfortunata prima dei Sei personaggi e poi sulla celebrazione per il premio Nobel vinto dal drammaturgo nel 1934, l’episodio cancellato traccia un arco tra picchi e valli nella carriera dell’autore, sottolineando il ruolo essenziale del rapporto tra padre e figlia, non solo a livello biografico ma anche per la sua funzionalità allo svolgimento della «commedia da fare».
Prendendo spunto da un’intervista di Pirandello del 1933, nella quale l’autore esprime la sua curiosità di veder trasformata in un’opera lirica i Sei personaggi, alessandra sorrentino dedica il suo interesse all’opera Six Characters in Search of an Author del compositore statunitense Hugo Weisgall, con libretto di Denis Johnston (1959). In quest’opera, gli attori sono sostituiti da cantanti che fanno una prova in un teatro d’opera di provincia americana, quando sono interrotti dai personaggi. Secondo l’analisi di Alessandra Sorrentino, quest’opera può essere considerata come una reinterpretazione del verismo europeo in chiave americana. Six Characters contiene una rivendicazione sociale articolata dai cantanti che vorrebbero negare ai personaggi, che non appartengono al sindacato, il diritto di mostrarsi sulla scena. Se, da un lato, la musica di Weisgall, essendo funzionale alla parola cantata, rispetta il messaggio del testo pirandelliano, accentuando il conflitto tra illusione e realtà, dall’altro, ci si manifesta una tendenza parodica, che risulta dal sincretismo degli elementi musicali (musica sacra, gospel, coro…). Il duetto tra il Padre e la Figliastra, col quale Pirandello, nell’intervista del 1933, aveva motivato la sua curiosità rispetto a una trasposizione musicale, è invece tradotto in musica in maniera tragica, a conformità del testo originale.
III. La dimensione della psicopatologia e dell’inconscio
Il contributo di alice malzacher verte su un luogo comune della critica pirandelliana, vale a dire il rapporto tra l’opera dell’agrigentino e il saggio di Alfred Binet su Les altérations de la personnalité, saggio che, com’è noto, colpì Pirandello per le affinità tra il suo lavoro artistico e le nuove frontiere della psichiatria. La novità del saggio di Alice Malzacher consiste in una rilettura parallela de Les altérations con l’impianto teorico dei Sei personaggi espresso nella celebre Prefazione del 1925. Vengono così alla luce analoghe categorie psicologiche, epistemologiche o letterarie, presenti e leggibili sia in chiave estetica, dalla parte di Pirandello, sia in chiave psichiatrica, dalla parte di Binet, che trova nel teatro uno spazio di esplicitazione e di dimostrazione dei propri assunti.
Details
- Pages
- X, 370
- Publication Year
- 2024
- ISBN (PDF)
- 9781803744568
- ISBN (ePUB)
- 9781803744575
- ISBN (Softcover)
- 9781803744551
- DOI
- 10.3726/b21728
- Language
- Italian
- Publication date
- 2024 (October)
- Keywords
- Interpersonal Relationships Pirandello Luigi (1867-1936) Drama Metatheatre Reception Adaptation Cinema Psychopathology Theology Fictionality Modernism
- Published
- Oxford, Berlin, Bruxelles, Chennai, Lausanne, New York, 2024. X, 370 pp.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG