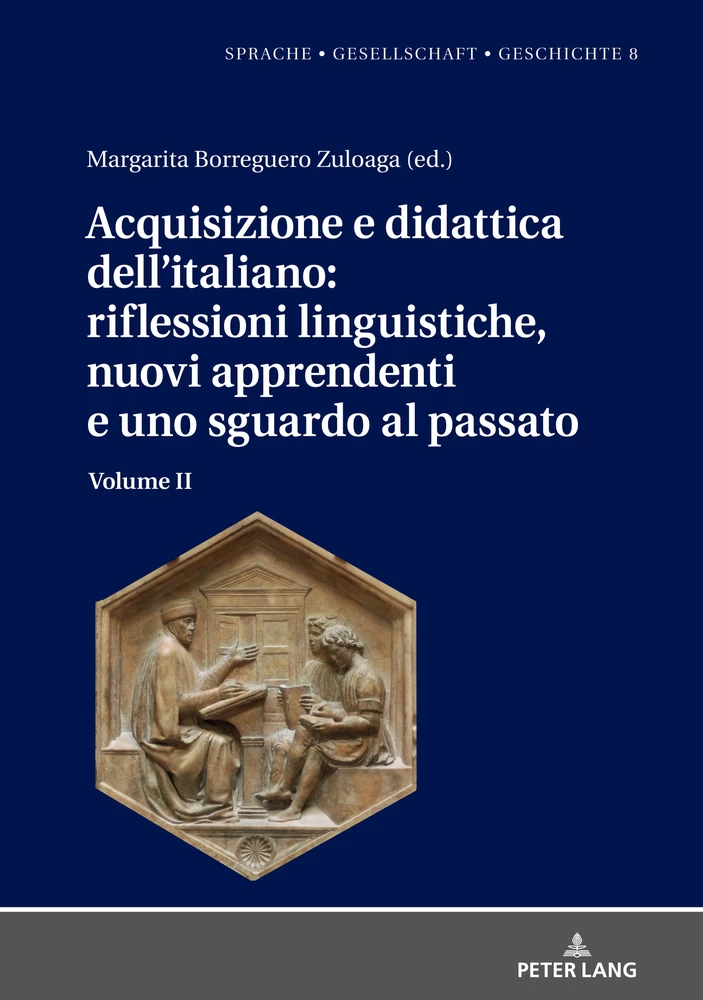Acquisizione e didattica dell’italiano: riflessioni linguistiche, nuovi apprendenti e uno sguardo al passato
Volume II
Summary
Excerpt
Table Of Contents
- Copertina
- Titolo
- Copyright
- Sull’autore
- Sul libro
- Questa edizione in formato eBook può essere citata
- Indice dei contenuti
- Elenco di Autori
- Terza parte DIDATTICA DELL’ITALIANO
- A. NUOVE PROPOSTE DIDATTICHE PER L’ITALIANO A SCUOLA
- Insegnare la variazione: “cattivi” modelli nella didattica dell’italiano (Paola Cantoni, Rita Fresu)
- La didattica della composizione scritta con le storie divergenti (Simone Fornara)
- MULTI – Piattaforma per l’italiano di scolarizzazione (Franca Bosc)
- B. MATERIALI E PROGETTI DIDATTICI PER L’ITALIANO LS
- Didattica della competenza conversazionale in italiano L2/LS: lo strumento A.Ma.Dis, una risorsa basata sulla ricerca acquisizionale (Eugenio Gillani, Paloma Pernas Izquierdo)
- “Lenguas de cuento”: un progetto per l’acquisizione della lingua italiana in Spagna in contesti di insegnamento presenziale, misto e online (Marina Sanfilippo, Eva Estebas Vilaplana)
- La traduzione audiovisiva e l’insegnamento dell’italiano LS: un’esperienza didattica (Ruska Ivanovska-Naskova, Irina Talevska)
- Il fumetto nell’insegnamento dell’italiano come lingua straniera (Giuseppe Maugeri, Graziano Serragiotto)
- Cantar l’italiano mimando: un esperimento pilota di micro-narrazione (Claudio Nobili)
- C. L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO ALL’ESTERO: APPRENDENTI OMOGENEI
- Il tempo e l’aspetto verbale in italiano e in ceco. Interferenza e apprendimento linguistico (Alessandro Bitonti, Valeria De Tommaso)
- Traduzione didattica L1-L2 nel percorso formativo del traduttore: analisi di fenomeni di transfer sintattico come stimolo della competenza interlinguistica (Giovanna Brianti)
- Lo sviluppo della competenza interculturale secondo i presupposti dell’approccio orientato all’azione (Marta Kaliska, Aleksandra Kostecka-Szewc)
- L’italiano LS in Germania: tendenze nella didattica delle lingue straniere nelle scuole della Renania Settentrionale-Vestfalia (Sara Colombo)
- L’apprendimento e l’insegnamento dell’italiano come LS per gli arabofoni. Un’indagine in Libia (Abuajila Elgheriwi)
- D. VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONI
- Criticità relative a testi di prove chiuse e semistrutturate tratti dalla certificazione di italiano LS CILS (Paolo Torresan)
- Le capacità gestionali dei docenti di italiano L2 negli esami di certificazione glottodidattica DILS-PG di II livello (Nicoletta Santeusanio)
- Quarta parte L’INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO ATTRAVERSO LA STORIA
- La Grammatica italiana delle Dame: suggerimenti per una sua storia (Gabriele Beck-Busse)
- A. TESTI CINQUECENTESCHI
- Osservazioni sulle citazioni nelle grammatiche cinquecentesche (Giuseppe Zarra)
- L’educazione linguistica cortese: conversare secondo il Galateo (Giovanna Alfonzetti)
- «Vogliamo che siano scritte di buona lettera e carateri Italiani». Linguaggio burocratico nel Piemonte del XVI secolo (Silvia Corino Rovano)
- B. GRAMMATICHE E METODI PER STRANIERI DAL SEICENTO AL NOVECENTO
- Il trattamento delle forme nominali nei più antichi manuali di grammatica croato-italiani (Vinko Kovačić)
- Su una sconosciuta grammatica italiana della fine del Settecento (Mila Samardžić)
- Il condizionale. Un’analisi delle grammatiche italiane pubblicate in Germania, Italia, Danimarca e Francia nel periodo 1838–1908 (Viggo Bank Jensen)
- La Gramática italiana di Francesc de B. Moll (Cesáreo Calvo Rigual)
- Metodi e approcci nei manuali dell’italiano L2 dal secondo dopoguerra ad oggi (Valentina Zenoni)
- Le grammatiche di riferimento per la lingua italiana per stranieri: teorie, varietà e aspetti pragmatici (Alessandra Cutrì)
- C. LA GRAMMATICA A SCUOLA: INNOVAZIONI E RIFORME DALL’OTTOCENTO FINO AD OGGI
- «Pigliar d’assalto la lingua italiana». Il metodo Capurro per le scuole reggimentali (Michela Dota)
- Alle origini del metodo “dal dialetto alla lingua”: Oscar Norreri e l’Avviamento allo studio dell’italiano nel comune di Castelmadama (1905) (Vincenzo D’Angelo)
- Lingua e grammatica nella scuola italiana del Ventennio. Appunti su materiali scolastici (Gabriella Macciocca)
- Verso una nuova grammatica scolastica. Spunti ed esempi dai manuali di grammatica italiana per la scuola media della prima metà del Novecento (Silvia Demartini)
- Dalla grammatica alle grammatiche dell’italiano: un’analisi in diacronia dei testi di educazione linguistica (1975–2015) (Luisa Amenta)
- La costruzione scenografica del sapere nei libri di testo delle discipline scientifiche (Marco Perugini)
- Quinta parte L’ITALIANO NEL MONDO
- L’italiano in Svizzera (Simone Fornara)
- L’italiano in Germania. Dati, problemi e prospettive dell’insegnamento (Sarah Dessì Schmid)
- L’italiano in Gran Bretagna (Richard Waltereit)
- L’italiano in Spagna (Paolo Silvestri)
- L’italiano dall’altra sponda dell’Adriatico (Julijana Vučo)
- Panorama dell’italianistica in Brasile (Maria Cecilia Casini e Tatiana Iegoroff de Mattos)
- Volumi pubblicati nella collana
Ana Albom
Università di Basilea Facoltà di Storia e Filosofia Sezione di Italianistica, Maiengasse 51 - 4056 Basilea, Svizzera. ana.albom@unibas.ch
Giovanna Alfonzetti
Università di Catania
Dipartimento di Scienze Umanistiche. Ex Monastero dei Benedettini, piazza Dante Alighieri 24, 95124 Catania. galfonz@unict.it
Luisa Amenta
Università di Palermo
Dipartimento di Scienze Umanistiche (Ed. 12) – Viale delle Scienze – 90128 Palermo. luisa.amenta@unipa.it
Marcello Amoruso
Università degli Studi di Palermo
Scuola di Lingua italiana per Stranieri, Dipartimento di Scienze Umanistiche, Viale delle Scienze, Ed. 12. marcello.amoruso@gmail.com
Adriana Arcuri
Università di Palermo
Scuola di Lingua italiana per Stranieri, Dipartimento di Scienze umanistiche, Piazza Sant’Antonino 1, 90134 Palermo. adriana.arcuri@istruzione.it
Viggo Bank Jensen
Università di Copenaghen
Institut for Engelsk, Germansk og Romansk, Københavns Universitet, Njalsgade 128, DK-2300 København S, Danmark. vbj@hum.ku.dk
Gabriele Beck-Busse
Philipps-Universität Marburg
Fachbereich Neuere Fremdsprachen, Institut für Romanische Philologie, Wilhelm-Röpke-Str. 6 D, D-35039 Marburg, beck-busse@staff.uni-marburg.de
Alessandro Bitonti
Università Masaryk (Brno)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav románských jazyků a literatur (Brno). alessandrobitonti@mail.muni.cz
Margarita Borreguero Zuloaga
Universidad Complutense de Madrid Departamento de Estudios Románicos, Franceses, Italianos y Traducción Avda. Profesor Aranguren s/n 28040 Madrid (España). mbzuloag@filol.ucm.es
Franca Bosc
Università degli Studi di Milano/Calcif
(Centro Linguistico di Ateneo per la promozione della lingua e della cultura italiana “Giuseppe e Chiara Feltrinelli), Via S. Sofia 9/1, 20100 Milano. franca.bosc@unimi.it
Eduardo Blasco Ferrer
Università di Cagliari
Cattedra di Linguistica romanza e sarda, Facoltà di Studi Umanistici, via Is Mirrionis 1 – I-09123 Cagliari. eblasco@libero.it
Giovanna Brianti
Università di Ginevra
Faculté de Traduction et d’Interprétation, Uni Mail, 40 bd. du Pont d’Arve, CH-1211 Genève 4, Svizzera. Giovanna.Titus-Brianti@unige.ch
Simona Brusco
Università degli Studi “Sapienza” di Roma
Dipartimento di Studi Orientali, ISO Istituto Italiano Studi Orientali, Scalo S. Lorenzo RM 21, Circonvallazione Tiburtina 4, 00185 Roma. simona.brusco@uniroma1.it
Cesáreo Calvo Rigual
Universitat de València – IULMA
Instituto Universitario de Lenguas Modernas Aplicadas. Avda. Blasco Ibáñez 32, E-46010 Valencia. Cesareo.Calvo@uv.es
Manuel Carrera Díaz
Universidad de Sevilla
Dpto. de Filologías integradas. Facultad de Filología. Universidad de Sevilla. c/ Palos de la Frontera s/n, 41004 Sevilla. carrera@us.es
Maria Cecilia Casini
Università di San Paolo del Brasile
Facoltà di Filosofia, Lettere e Scienze Umane, Dipartimento di Lettere Moderne. Rua do Lago 717 – Cidade Universitária, San Paolo – SP 05508–080, Brasile. casini@usp.br
Paola Cantoni
Università di Roma “La Sapienza”
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi greco-latini, italiani, scenico-musicali, Piazzale Aldo Moro 5, I-00185 Roma. paola.cantoni@uniroma1.it
Salvatore Cavaliere
Università di Banja Luka
Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A, 78000 Banja Luka, Bosnia ed Erzegovina. salvatore.cavaliere@unibl.rs
Marina Chini
Università di Pavia
Dipartimento di Studi Umanistici, Sezione di Linguistica Teorica e Applicata, Corso Strada Nuova 65 – 27100 Pavia. marina.chini@unipv.it
Luca Cignetti
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA), Piazza S. Francesco 1, 6900 – Locarno, Svizzera. Luca.Cignetti@supsi.ch
Doriana Cimmino
Università di Basilea Facoltà di Storia e Filosofia Sezione di Italianistica, Maiengasse 51, 4056 Basilea, Svizzera. doriana.cimmino@unibas.ch
Laura Clemenzi
Università degli Studi della Tuscia
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), via San Carlo 32, 01100 – Viterbo. laura.clemenzi@unitus.it
Sara Colombo
Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn, Philosophische Fakultät, Abteilung Romanistik, Am Hof 1, 53111 Bonn. sara.colombo@uni-bonn.de
Federica Cominetti
Università di Pisa
Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica. Università di Pisa. Piazza Torricelli 2 – 56126 Pisa. fedcominetti@gmail.com
Elisa Corino
Università di Torino
Dipartimento di Lingue e letterature straniere e Culture moderne, via Verdi 10 – 10124 Torino. elisa.corino@unito.it
Silvia Corino Rovano
Università degli Studi di Torino
Facoltà di Scienze della Formazione, Dipartimento di Filosofia e Scienze dell’Educazione. scorinor@unito.it
Alessandra Cutrì
Università per Stranieri di Perugia
Piazza Fortebraccio 4, 06123 Perugia, Dipartimento di Scienze umane e sociali, Dottorato di ricerca in Scienze linguistiche e filologiche. alessandra.cutri@unistrapg.it
Mari D’Agostino
Università degli Studi di Palermo
Piazza Sant’Antonino, 1 – 90134 Palermo. mari.dagostino@unipa.it
Alberto D’alfonso
Università per Stranieri di Siena
Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca, Piazza Carlo Rosselli 27/28 – 53100 Siena. dalfonso@unistrasi.it
Vincenzo D’Angelo
Istituto Italiano per gli Studi Storici
Via Benedetto Croce 12, 80134 Napoli. vince.dangelo@gmail.com
Anna-Maria De Cesare
Università di Basilea
Facoltà di Storia e Filosofia/Sezione di Italianistica, Maiengasse 51, 4056 Basilea, Svizzera. anna-maria.decesare@unibas.ch
Silvia Demartini
DFA (Dipartimento Formazione e Apprendimento),
SUPSI (Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana)
Piazza San Francesco 19, 6600 Locarno, Svizzera. silvia.demartini@supsi.ch
Sarah Dessì Schmid
Eberhard Karls Universität Tübingen
Romanisches Seminar, Wilhelmstr. 50, 72074 Tübingen. sarah.dessi@uni-tuebingen.de
Valeria De Tommaso
Università Masaryk (Brno)
Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Ústav románských jazyků a literatur, Brno. detommaso@mail.muni.cz
Michela Dota
Università degli Studi di Milano
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi letterari, filologici e linguistici, Via Festa del Perdono 7 – 20122 Milano. Michela.Dota@unimi.it
Abuajila Elgheriwi
Università degli Studi di Palermo
Dipartimento di Scienze Umanistiche, Viale delle Scienze, Ed. 12, 90128 Palermo. a.elgrewi@yahoo.com
Eva Estebas Vilaplana
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Facultad de Filología, UNED, Senda del Rey 7, 28040 Madrid. eestabas@flog.uned.es
Simone Fornara
SUPSI DFA
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana, Dipartimento Formazione e Apprendimento, Piazza San Francesco 19, CH-6600 Locarno. simone.fornara@supsi.ch
Rita Fresu
Università di Cagliari
Facoltà di Studi Umanistici, Dipartimento di Filologia, Letteratura, Linguistica, via Is Mirronis 1 – I-09123 Cagliari. rfresu@unica.it
Francesca Gatta
Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione, Università di Bologna, sede di Forlì. francesca.gatta@unibo.it
Vittorio Ganfi
Università degli Studi di Roma Tre
Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo, Via Ostiense 236, 00144 Roma. vittorio.ganfi@uniroma3.it
Eugenio Gillani
Escuela Oficial de Idiomas di Alcalá de Henares,
C/ Daoíz y Velarde 30, 28807 Alcalá de Henares, España. eugillani@gmail.com
Sara Giulivi
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI)
Dipartimento Formazione e Apprendimento (DFA), Piazza S. Francesco 1, 6900 – Locarno, Svizzera. Sara.Giulivi@supsi.ch
Riccardo Gualdo
Università degli Studi della Tuscia
Dipartimento di studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU), via San Carlo 32, 01100 – Viterbo. gualdo@unitus.it
Tatiana Iegoroff de Mattos
Università di San Paolo del Brasile
Facoltà di Filosofia, Lettere e Scienze Umane, Dipartimento di Lettere Moderne. Rua do Lago 717 – Cidade Universitária, San Paolo – SP 05508–080, Brasile. tatiana.mattos@usp.br.
Ciro Imperato
Università di Helsinki
Faculty of Arts, Department of Modern Languages (Italian Philology). Unioninkatu 40. PL 2400014 Helsingin yliopisto. ciro.imperato@helsinki.fi
Ruska Ivanovska-Naskova
Università “Ss. Cirillo e Metodio” di Skopje
Facoltà di Filologia “Blaže Koneski”, Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana, bul. Goce Delčev 9a, 1000 Skopje, Macedonia. rivanovska@flf.ukim.edu.mk
Marta Kaliska
Uniwersytet Warszawski WLS, ul. Szturmowa 4, 02-678, Varsavia, Polonia. m.kaliska@uw.edu.pl
Iørn Korzen
Copenhagen Business School
Department of Management, Society and Communication, Dalgas Have 15, DK-2000 Frederiksberg. ik.ibc@cbs.dk
Aleksandra Kostecka-Szewc
Uniwersytet SWPS, Facoltà di Scienze Umanistiche e Sociali, Dipartimento di Italianistica,ul Chodakowska 19/31 00-001 Varsavia, Polonia. akostecka-szewc@swps.edu.pl
Vinko Kovačić
Università di Zagabria
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Italianistica. vkovacic@ffzg.hr
Katarzyna Kwapisz-Osadnik
Università della Slesia, Istituto di Lingue Romanze e di Traduttologia
Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne dell’Università della Slesia, 41–205 Sosnowiec, ul. Grota- Roweckiego 5, Polonia. kkwapisz@icloud.com
Francesca La Forgia
Università degli Studi di Bologna
Dipartimento di Interpretazione e Traduzione, Scuola di Lingue e Letterature, Traduzione e Interpretazione, Università di Bologna, sede di Forlì. francesca.laforgia3@unibo.it
Nicolangela Leopardi
Università di Firenze
Centro di Cultura per Stranieri – Università di Firenze, via Francesco Valori 9, 50132, Firenze. nicolangelaleopardi@gmail.com
Gabriella Macciocca
Università di Cagliari
Facoltà di Studi umanistici, Dipartimento di pedagogia, psicologia, filosofia, Via Is Mirrionis 1, 09123 Cagliari. gmacciocca@unica.it
Viviana Masia
Università degli Studi di Genova
Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR), sezione di Psicologia Generale, Corso Andrea Podestà 2, 16128 Genova. viviana.masia@gmail.com
Giuseppe Maugeri
Università Ca’ Foscari di Venezia
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, 30123 Venezia. gmaugeri@unive.it
Emma Milano
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Dipartimento di Studi Umanistici. Via Porta di Massa 1, 80132 Napoli. milemma@unina.it
Egle Mocciaro
Università di Palermo
Scuola di Lingua italiana per Stranieri, Dipartimento di Scienze umanistiche, Piazza Sant’Antonino 1, 90134, Palermo. egle.mocciaro@unipa.it
Claudio Nobili
Università di Gent
Facoltà di Lettere e Filosofia, Dipartimento di Studi letterari, Blandijnberg 2, 9000 Gent, Belgio. Claudio.Nobili@UGent.be
Paloma Pernas Izquierdo
Escuela Oficial de Idiomas di Segovia
c/ Ochoa Ondátegui s/n, 40001 Segovia, España. paloma.pernasizquierdo@gmail.com
Marco Perugini
Università degli studi “Guglielmo Marconi” Roma
Via Plinio 44, 00193 Roma. perugimar@libero.it
Luisa Revelli
Università della Valle d’Aosta
Dipartimento di Scienze Umane e Sociali Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini 2/A – 11100 Aosta. l.revelli@univda.it
Mila Samardžić
Università di Belgrado
Facoltà di Filologia, Studentski trg 3, 11000 Beograd, Serbia. milasamardzic@fil.bg.ac.rs
Marina Sanfilippo
Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED)
Facultad de Filología, Senda del Rey 7, 28040 Madrid. msanfilippo@flog.uned.es
Nicoletta Santeusanio
Università per Stranieri di Perugia – CVCL, Viale Carlo Manuali 5, 06121 Perugia. n.santeusanio@unistrapg.it
Graziano Serragiotto
Università Ca’ Foscari di Venezia
Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali Comparati, 30123 Venezia. serragiotto@unive.it
Paolo Silvestri
Universidad de Sevilla
Facultad de Filología. c/ Palos de la Frontera s/n, 41004 Sevilla. psilvestri@us.es
Roska Stojmenova
Università di Basilea
Istituto di Italianistica, Maiengasse 51 – 4056 Basel (CH).
Irina Talevska
Università “Ss. Cirillo e Metodio” di Skopje
Facoltà di Filologia “Blaže Koneski”, Dipartimento di Lingua e Letteratura italiana, bul. Goce Delčev 9a, 1000 Skopje, Macedonia. irinatalevska@flf.ukim.edu.mk
Mirko Tavosanis
Università di Pisa
Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica. Piazza Torricelli 2 – 56126 Pisa. mirko.tavosanis@unipi.it
Paolo Torresan
Universidade Federal Fluminense
Instituto de Letras, Departamento de Letras Estrangeiras Modernas, Campus do Gragoatá, Bloco C, 24.220–900, Niterói, Brasil. esh@unive.it
Ida Tucci
Università di Firenze
Centro di Cultura per Stranieri, via Francesco Valori 9, 50132 Firenze. ida.tucci@gmail.com
Manuela Visigalli
Università di Bologna
Centro Linguistico di Ateneo, Piazza S. Giovanni in Monte 4, 40124 Bologna. manuela.visigalli@unibo.it
Julijana Vučo
Università di Belgrado
Facoltà di Filologia, Dipartimento di Lingua e Letteratura, Studentski trg 3, 11000 Belgrado, Serbia. julivuco@gmail.com
Richard Waltereit
Humboldt-Universität zu Berlin
Sprach- und literaturwissenschaftliche Fakultät. Institut für Romanistik. Unter den Linden 6, D-10099 Berlin. richard.waltereit@hu-berlin.de
Giuseppe Zarra
Istituto Opera del Vocabolario Italiano (OVI) del Consiglio Nazionale delle Ricerche, via di Castello 46, 50141 Firenze. giuzarra@hotmail.it
Valentina Zenoni
Università degli Studi di Milano
Centro d’Ateneo per la Promozione della Lingua e della Cultura italiana “Chiara e Giuseppe Feltrinelli” (CALCIF), via Santa Sofia 9/1, 20122 Milano. valentina.zenoni@unimi.it
Paola Cantoni, Rita Fresu
Insegnare la variazione: “cattivi” modelli nella didattica dell’italiano
RIASSUNTO L’acquisizione dell’italiano come “lingua variabile”, promossa ormai da tempo dagli studi teorici e ribadita anche nelle ultime Indicazioni e Linee Guida, stenta ad affermarsi nella concreta pratica scolastica. Appare perciò necessario mettere a punto nuovi modelli per promuovere una competenza linguistica fondata sul concetto di variazione e fornire ai docenti metodi, sfondi teorici, contenuti ed anche proposte didattiche concrete. Il presente intervento intende illustrare le potenzialità in sede didattica di testi non letterari e proporre, sulla base di esperimenti testati anche attraverso esperienze personali, alcuni percorsi operativi. Le produzioni dal basso, oggetto negli ultimi tempi di ripensamenti teorici sul piano storico- e socio-linguistico, presentano diversi vantaggi sia di ordine metodologico sia per i contenuti che veicolano e per i contesti che evocano e che le aprono alla possibilità di percorsi disciplinari trasversali. Sono qui presentati e discussi alcuni casi concretamente sperimentati che consentono di mettere a fuoco gli elementi di forza e le ricadute reali di tali testi nella didattica dell’italiano.
Parole chiave: didattica, variazione linguistica, italiano, testi non letterari.
ABSTRACT The acquisition of Italian as a variable language, promoted by theoretical studies for some time now and reiterated in the latest Indicazioni and Linee Guida, struggles to establish itself in the actual school practice. Therefore, it seems necessary to develop new models in order to encourage a linguistic competence based on the concept of variation and to provide teachers with methods, theoretical backgrounds, contents as well as concrete educational proposals. This paper has the purpose of illustrating the potentialities of non-literary texts in schools and proposing some operating paths, on the basis of experiments tested also through personal experiences. The productions from below, that have been recently subject of theoretical thoughts at the historical and socio-linguistic level, have several advantages both methodological and for the content they carry and for contexts that they evoke and that open up the possibility of cross-disciplinary courses. They are here presented and discussed some cases actually experienced that allow to focus on the elements of strength and the real impact of such texts on teaching Italian.
Keywords: teaching language, variable language, Italian language, non-literary texts.
SOMMARIO: 1. Modelli variabili 2. Testi e proposte didattiche 2.1. Primo percorso: Adorabile Cigliola… Lettere a Gigliola Cinquetti 2.2. Secondo percorso: Me se tipo… Commenti ai post di fb 2.3. Terzo percorso: Doie parole… Raffaele Vivani alla moglie Maria Di Maio 2.4. Quarto percorso: Di pirsona pirsonalmenti… La parodia del semicolto 3. Progetti scolastici 4. Dalla ricerca alla didattica.
Gli errori sono necessari,
utili come il pane e spesso anche belli
G. Rodari, Il libro degli errori,
Torino, Einaudi, (1964) 1993, p. 7.
1. MODELLI VARIABILI1
Fatta eccezione per alcuni àmbiti specifici (la semantica, ad esempio), la variazione linguistica resta ancora poco praticata nella prassi didattica. Il mutamento linguistico, la storia della lingua, le dinamiche sociali del linguaggio (con l’attenzione alle variabili geografiche e socioculturali), le relazioni tra i fatti linguistici e la dimensione psicologica solo raramente sono oggetto di studio o di riflessione nella concreta pratica scolastica.
Accade ciò malgrado il fatto che l’acquisizione dell’italiano come lingua variabile sia stata da tempo promossa dagli studi teorici e, soprattutto, sia stata riconosciuta come una priorità didattica (cfr. almeno Lo Duca 2003. Lavinio 2011), ribadita anche nelle ultime Indicazioni ministeriali e Linee Guida (2010 e 2012). Tra i molti spunti possibili, basti qui richiamare l’attenzione sulla necessità (espressa tra gli obiettivi per la scuola media) di sollecitare nei giovani il riconoscimento della multiforme varietà linguistica italiana (Linee Guida 2010 e 2012: 34–35) e – anche per la pertinenza con quanto di seguito si dirà – sulla raccomandazione di condurre il discente a riflettere sugli errori, a partire dai propri (Linee Guida 2010 e 2012: 36).
Si tratta, innanzitutto, di un problema connesso alla formazione degli insegnanti, sull’importanza della quale più studiosi si sono recentemente soffermati; ci limitiamo a rievocare l’intervento di Francesco Sabatini (2014: 231–232; ora, in prospettiva generale, cfr. anche Sabatini 2016, in particolare pp. 201–204) il quale ricorda come sia mancata, in passato, nei percorsi formativi diretti all’insegnamento una specificità linguistica, e di quanto l’addestramento dei futuri docenti sia stato dominato, come è noto, da una attenzione privilegiata al testo letterario (anche per la preoccupazione di proporre “buoni modelli”). Quest’ultimo è stato oggetto di riserve anche da parte di Luca Serianni (2014c: 2), che ne ha indicato alcune “controindicazioni” didattiche (ma sull’impiego della letteratura a scuola cfr. anche Serianni 2010: 84–94):
per cogliere gli snodi argomentativi di un testo, per gerarchizzarne le informazioni salienti il testo letterario è doppiamente controindicato: da un lato perché il suo potenziale educativo va in un’altra direzione, quella di far riconoscere ed esprimere adeguatamente sentimenti ed emozioni e di sviluppare l’immaginario; dall’altro perché sottoporre il testo letterario a esercizi (a partire dalla prova principe per misurare la reale comprensione di un testo, il riassunto) significa svilire il suo carattere intrinsecamente plurivoco e spegnere inevitabilmente nel discente ogni piacere per la lettura.
La difficoltà dei giovani di adeguare la comunicazione ai differenti contesti – frequentemente lamentata in sede di teoria didattica – rappresenta spesso la ricaduta negativa di un insegnamento dell’italiano inteso come modello “unico”, che in tale modo – della lingua – offre una visione parziale. Appare quindi necessario mettere a punto strategie per promuovere una competenza linguistica fondata sul concetto di variazione e fornire ai docenti metodi, sfondi teorici, contenuti ed anche proposte didattiche concrete.
A partire da queste considerazioni, il presente intervento intende illustrare le potenzialità in sede didattica di testi non letterari e proporre, sulla base di esperimenti personalmente testati, alcuni percorsi operativi.
Details
- Pages
- XXII, 682
- Publication Year
- 2021
- ISBN (PDF)
- 9783631865590
- ISBN (ePUB)
- 9783631865606
- ISBN (MOBI)
- 9783631865613
- ISBN (Hardcover)
- 9783631861523
- DOI
- 10.3726/b18919
- Language
- Italian
- Publication date
- 2021 (September)
- Published
- Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 2021. XXII, 682 p., 89 ill. b/n, 16 tab.
- Product Safety
- Peter Lang Group AG